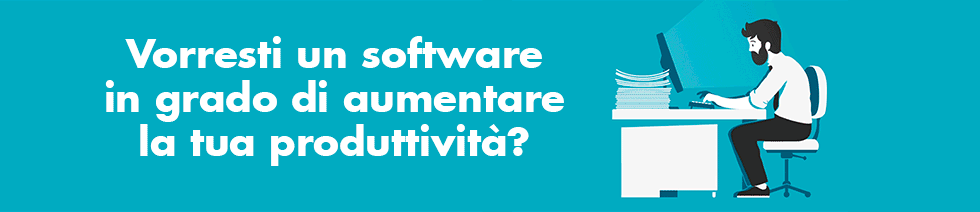Alla salute, dice chi beve,
mai che lo dica quando mangia.
(Jerome)
La verità è nel vino e nei fanciulli.
(Platone)
Gli antichi avevano sempre sete, sete di vino, e non lo tracannavano schietto ma battezzato, ossia mescolato con acqua calda o tiepida, un miscuglio da fare inorridire i nostri veronelli. Forse facevano così per non prendere la sbornia subito all’antipasto dato che i loro banchetti duravano a lungo, come quelli che erano soliti imbandire Trimalcione, uomo ricchissimo a cui tutto nasce in casa, dai limoni al pepe e al latte di gallina, e Apicio, insuperabile nelle gozzoviglie, e soprattutto Lucio Licinio Lucullo.
Questo personaggio, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, compì numerose e gloriose imprese di guerra, come quella di sconfiggere Mitridate re del Ponto. I migliori anni della sua vita (tra l’altro piuttosto breve) li spese sui campi di battaglia a combattere i nemici di Roma, ciò che ha dato al suo nome un posto di tutto rispetto nei libri di storia. Ma chi sfoglia il vocabolario e s’imbatte nell’aggettivo luculliano, ora, dice, mi si snocciolano tutte le imprese compiute dal generale Lucullo, e invece rimane deluso e deve prendere atto che il suddetto aggettivo non si riferisce alle sue virtù militari, bensì ai pranzi e alle cene, non proprio francescani, che, una volta in congedo, imbandiva per sé e per gli amici. I suoi banchetti erano infatti memorabili e gli costavano somme favolose, che per lui, comunque, erano spiccioli, se si fa il conto dei tesori che aveva rastrellato durante le sue campagne di guerra.
Non so se anche alla mensa di Lucullo i convitati bevessero vino battezzato. Questa usanza certamente non sarebbe andata a genio al patriarca Noè, il quale, dopo il diluvio, si dette all’agricoltura e subito piantò una vigna. Forse non sapeva neanche lui che razza di frutto sarebbe nato e quali effetti avrebbe provocato, soprattutto se spremuto coi piedi in un tino. Egli bevve e ribevve quel liquido che venne fuori da questa operazione di spremitura, tanto da prendersi una solenne e memorabile sbornia, in assoluto la prima che si ricordi. Si mise a dormire saporitamente sotto la sua tenda, nudo come lo aveva fatto sua madre, ma due dei suoi giovani figli (avranno avuto poco più di cent’anni) ne coprirono le vergogne con un mantello.
Un’altra ubriacatura, anch’essa di vino schietto e questa volta collettiva, avvenne nella reggia di Alessandro Magno. Al ritorno da una cerimonia funebre, il re invitò a pranzo amici e generali a cui propose di fare a gara a chi avesse bevuto la maggiore quantità di vino. La vinse Promaco, il quale ne tracannò quattro congi, che sarebbero più di 13 litri, beccandosi una sbornia che gli durò tre giorni, dopo i quali morì, e con lui – forse a causa del freddo che subentrò ai calori del vino – morirono altri quarantuno ex bevitori. Salute! E giacché è stato rammentato Alessandro Magno, bisogna dire che francamente non ci saremmo aspettati da lui un comportamento del genere, lui che aveva avuto come precettore nientemeno che Aristotele, il filosofo di Stagira, il quale non nutriva molta simpatia per il vino, anzi affermava che uno che ha bevuto può fare soltanto discorsi strampalati. No, caro Aristotele, lo corregge Monsignor Della Casa: quel buon uomo di Socrate (così lo chiama) ne reggeva anche un tino, tant’è che bevve per una notte quanto è lunga e la mattina dopo, all’alba, risolse un difficile calcolo geometrico senza fare il minimo errore.
Ecco, ho tirato in ballo la filosofia e allora vorrei parlare di quattro filosofi della Grecia antica ai quali piaceva sia il bere sia il sapere, ma a tutti e quattro il vino giocò un tiro mancino, tanto che non hanno potuto raccontarlo. Il primo è Arcesilao, il quale morì a 75 anni per il fatto che il troppo vino che aveva bevuto gli fece girare la testa per cui scivolò e cadde malamente a terra. Un suo allievo di nome Lacide imparò bene le lezioni del maestro, tanto è vero che aveva molta dimestichezza con la filosofia e di più col vino, e una volta ne bevve così tanto che gli venne una paralisi e addio anche a lui. Sulla morte di Epicuro, a 72 anni, si danno due versioni: la prima che sia morto di calcoli renali dopo una malattia durata due settimane, e la seconda, forse la vera, che un giorno volle fare il bagno, entrò in una tinozza piena d’acqua calda e intanto trincava un boccale dietro l’altro: troppo ne bevve tanto che morì col vino in bocca e i piedi nell’acqua. Per ultimo vi dirò di Crisippo il secco, e anche sulla sua morte ci sono due versioni, entrambe che chiamano in causa il vino. Una dice che il filosofo morì a 73 anni perché bevve d’un solo fiato un boccale di vino dolce non mescolato, fu preso da vertigini e dopo cinque giorni lasciò questo mondo. L’altra tira in ballo un suo asino che aveva mangiato alcuni fichi, e allora il padrone ordinò alla sua vecchia perpetua di dargli del vino puro (all’asino), così li avrebbe digeriti meglio (i fichi), e quando Crisippo vide quella povera bestia ubriaca fradicia che ciondolava sulle quattro zampe, scoppiò in una bella risata che fu l’ultima della sua vita. Morì dal ridere, beato lui.
Ora lasciamo in pace i quattro filosofi greci e con un bel salto in lungo, fino a raggiungere il primo secolo dopo Cristo, trasferiamoci a Roma per sentire come vanno le cose da quelle parti. Già durante la repubblica il vino era merce da tassare, e se lo tassavano i repubblicani perché l’imperatore non avrebbe dovuto seguire il loro esempio? Così i produttori di vino (ma anche quelli che producevano olio) continuarono a pagare la cosiddetta decima. In sostanza, questi signori contribuenti, se ricavavano dalla vendemmia, tanto per dire, cento damigiane di vino, dieci le dovevano dare allo stato, che le rivendeva o le assegnava alla truppa. Prima però c’erano alcuni assaggiatori, oggi li chiameremmo sommelier, i quali avevano l’incarico di individuare il vino più pregiato e riporlo al fresco nelle cantine imperiali. Alla salute dell’imperatore.
A questo punto si fa una breve visita a un signore romano di nome Papilo, ospitale anfitrione, che organizzava spesso cene e desinari e la cui generosità, a detta di Marziale, era molto apprezzata, ma c’è un ma. L’apprezzamento era incondizionato per quanto riguardava le vivande, invece per le libagioni era davvero un disastro. Infatti gli invitati che sedevano alla sua mensa mangiavano a quattro palmenti, ma vuoi vedere che erano tutti astemi, visto che non assaggiavano neanche un goccio di vino? Incredibile, tanto più se si pensa che il padrone di casa non è che offrisse vinelli da tre soldi, tutt’altro. Egli possedeva una cantina ben fornita con centinaia di bottiglie polverose che contenevano i vini più celebrati e tra questi i celeberrimi di Sezze e del monte Massico in Campania. Come si spiega allora che per l’intera durata del banchetto – e si sa che durava ore e ore – tutti i commensali si abbuffavano di cibo ma nessuno chiedeva che gli venisse riempito il bicchiere di vino? Il fatto è che c’era un precedente, anzi quattro per l’esattezza. Papilo era vedovo, è una disgrazia che succede, ma lui ne aveva avute quattro di disgrazie e infatti era vedovo di quattro mogli, le quali se n’erano andate, una dietro l’altra – così si mormorava –, dopo aver bevuto il vino che l’affettuoso marito metteva in tavola. Figuriamoci se i commensali prestavano fede a queste malelingue, ci mancherebbe altro. Tuttavia non era male usare un po’ di prudenza, che non per nulla è una delle quattro virtù cardinali. Ma almeno, affinché agli ospiti andasse giù il boccone, c’era sulla tavola una bottiglia d’acqua minerale Ferrarelle?
Molto tempo prima che il vino mandasse all’altro mondo Promaco e i suoi compagni, i quattro illustrissimi filosofi greci, nonché le quattro povere spose di Papilo, il vino ne aveva combinata un’altra e questa volta veramente grossa, qual è quella della calata dei galli in Italia.
Possibile che il vino sia il responsabile di questa disastrosa invasione? Sì, è possibile, anzi è più che sicuro. La cosa andò in questo modo. I galli se ne stavano nelle loro terre, alcuni a settentrione dell’Europa, altri tra i Pirenei e le Alpi, ossia in Francia (tanto è vero che una volta la Francia si chiamava Gallia), e non avevano nessuna intenzione di abbandonarle, visto che in quei luoghi si trovavano bene e molti giovanotti avevano casa, moglie e figlioli. Ora successe che un giorno capita tra loro un certo Arronte, forse un vignaiolo o un mercante, il quale era stato piantato dalla moglie. Per consolarsi si dedicò all’esportazione di una bevanda che nel territorio dei galli nessuno aveva mai visto e tanto meno assaggiato: era di colore bianco o rosso e anche rosato e di ottimo sapore e questo bendidio veniva prodotto in Italia e si chiamava vino, parola che nessuno di loro aveva mai sentito nominare. Ne bastò un sorso per mandare in estasi chi l’assaggiò. La voce si sparse in un baleno per miglia e miglia: se esisteva una terra così generosa dove si poteva bere un liquido tanto prelibato, che ci stiamo a fare in questi luoghi? Presero armi e bagagli e cominciarono il trasloco: varcarono le Alpi, approdarono in Italia, e siccome avevano la gola secca per la polvere e lo strapazzo del viaggio, si sparpagliarono di qua e di là e si concessero subito solenni bevute.
Erano approdati in quei territori settentrionali che oggi si chiamano Lombardia, Piemonte, Trentino e così via, dove il vino si può dire che sgorgava dalle fontane da tanto che ce n’era: di colore rosso, nero, bianco, rosato, e per tutti i gusti: dolce, amarognolo, frizzante, vecchio e novello, abboccato, vellutato, amabile, pastoso, delicato, asciutto e liquoroso. Mancava l’etichetta su fiaschi e bottiglie ma si trattava di merce a denominazione d’origine controllata, anzi, controllata e garantita, tipo il Barolo, il Grignolino, il Barbaresco e la Barbera, il Dolcetto, il Nebbiolo, il Franciacorta, il Merlot e il Pinot, nè mancavano l’Amarone, il Valpolicella e il Bardolino. A mano a mano che scendevano verso sud ebbero modo di farsi altre solenni bevute di Cinqueterre, di Sangiovese e Lambrusco, e in Toscana scoprirono il Chianti, il Brunello di Montalcino, la Vernaccia, il Montecarlo, il Montepulciano (d’ogni vino è il re, dice Bacco, nel Bacco in Toscana di Francesco Redi) e poi – chi non beve in compagnia è un ladro o una spia, e bevi tu che bevo anch’io – il Verdicchio e l’Orvieto. Avevano ormai occupato l’intero territorio degli antichi etruschi, i quali erano stati cacciati senza tanti complimenti e al loro posto si piazzarono i galli che diventarono i nuovi padroni del territorio. Un giorno – erano trascorsi non so mai quanti anni da tale occupazione – sorsero dei contrasti con gli abitanti di Chiusi. Questa città chiese aiuto a Roma, che era potente e non lontana, e Roma mandò contro i galli almeno 40.000 fanti, i quali, però, furono colti di sorpresa nell’accampamento che avevano allestito nei pressi di un affluente del Tevere: pochi riuscirono a fuggire e tutti gli altri vennero uccisi. Era il 18 luglio del 390 avanti Cristo, e Brenno, il comandante in capo dei galli, concesse una sosta ai suoi uomini affinché si spartissero il bottino catturato ai romani, e per celebrare la vittoria niente di meglio di qualche fiasco di Frascati e di Marino, e a Montefiascone, in provincia di Viterbo, cari signori galli, fermi tutti perché c’è un Trebbiano da leccarsi i baffi.
Non giurerei che a quei tempi (ricordiamoci che parlo di quasi 2400 anni fa) nelle osterie si mescessero i vini con le etichette che ho rammentato. Ma la cosa ha poca importanza: ce n’erano tanti e tutti eccellenti, in grado di soddisfare anche il più sopraffino dei palati e di far venire sete anche a chi non ce l’ha. I galli ce l’hanno la sete, seguitano a trincare a garganella, e uno che beve mi sembra giusto che venga lasciato in pace. Così ne approfitto per raccontare una storia, accaduta probabilmente intorno al 1100, che riguarda, appunto, un certo vino di Montefiascone.
In realtà c’è chi la racconta in un modo e chi nell’altro, ma, pur cambiando i personaggi e il tempo in cui s’è svolta, il risultato non cambia. Io seguo la versione più accreditata che è questa: c’era una volta un vescovo tedesco (altri dicono un barone, ma sempre tedesco era) il quale anche lui, come i galli, aveva varcato le Alpi e si dirigeva verso sud. A questo monsignore (o barone che fosse) piaceva molto il vino, di quello buono, però, e allora, per non incappare male, ossia per non entrare in qualche osteria sfornita di quello gradito al suo palato sopraffino, aveva ordinato a un uomo del suo seguito, uno che se ne intendeva, di andare avanti a cavallo e di bersi un gotto in ogni osteria che incontrava. E dopo l’assaggio, se il vino era cattivo, via di corsa, ma se era buono lo doveva gridare a squarciagola, anzi, meglio scrivere sulla porta EST, sottinteso bonum, ossia è buono. Succede che quel signore a cavallo arriva in provincia di Viterbo, precisamente a Montefiascone. Come gli aveva ordinato il vescovo (o il barone), entra in un’osteria, ne sorseggia un bicchiere e poi, invece di girare i tacchi, ne bevve un altro e un altro ancora e quando esce, sulla porta ci scrive tre volte EST, con tanto di punto esclamativo, così: EST! EST! EST! Tre volte buono, dunque, sicché arriva il vescovo (o il barone), vede la scritta, entra nell’osteria e non si sa quanto ne bevve, certamente un fiume ne bevve, e morì che neanche se ne accorse, povero vescovo (o povero barone) perché la testa l’aveva tra le nuvole.
Ora bisogna tornare ai galli i quali, dopo le abbondanti libagioni per celebrare la loro vittoria, marciano su Roma, preda ambitissima, che nel frattempo era stata abbandonata dai romani. Ed è un peccato, almeno dal punto di vista delle bevute, che qui si fermino perché, se avessero proseguito verso sud, avrebbero potuto farne ancora di eccellenti col Biferno e il Falerno, l’Aglianico e il Brindisi, e la Terraccia calabrese, e magari una puntata in Sicilia per qualche bicchiere di Corvo e di Marsala, e in Sardegna a scoprire il Vermentino e il Cannonau, e dappertutto, in terraferma o nelle isole, l’aleatico, il passito, il vinsanto, magari con qualche cantuccino da zuppare. No, si fermano a Roma – così ordina il loro comandante –, la mettono a ferro e fuoco, e altrettanto fanno nelle campagne vicine. Finalmente, dopo sette mesi di permanenza, dal 20 luglio del 390 fino al 13 di febbraio del 389, ritennero che fosse giunta l’ora di levare le tende, a una condizione però: siccome non erano contenti di quanto avevano rubato, imposero ai romani che aprissero la loro cassaforte e gli consegnassero l’oro che custodiva.