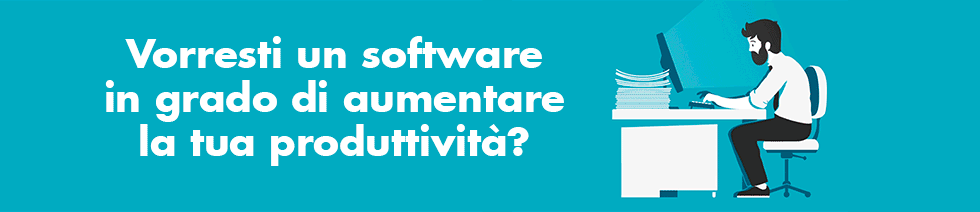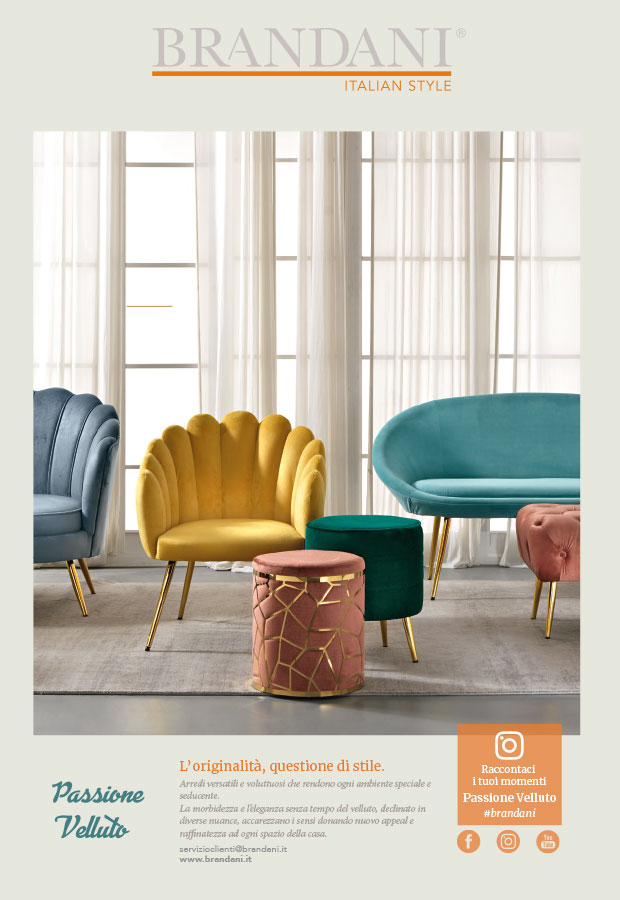Verità. I nostri discorsi non sembrano dominati da altro. Ne parliamo, la presupponiamo, la pretendiamo, ma sappiamo cos’è la verità? Nel vangelo di Giovanni Pilato rivolge a Gesù la stessa domanda. Gesù non risponde e con il suo silenzio palesa, forse, l’indicibilità della verità. Gli Scettici antichi di fronte all’impossibilità di esprimere un giudizio certo preferivano tacere. La chiamavano afasia. Le parole velano, talvolta, più che svelare il contenuto. Da qui gli errori di giudizio; da qui odio e incomprensione.
Alla fine del ‘600, in un Europa piagata dalle guerre, Gottfried Wilhelm Leibniz, filosofo, matematico e diplomatico tedesco, elaborò il progetto di un linguaggio logico universale, la «caratteristica universale», che avrebbe dato la possibilità all’uomo di pervenire alla verità in modo automatico e universalmente valido. Controversie filosofiche e dispute di ogni genere sarebbero state risolte meccanicamente a partire da assiomi indubitabili. La ricetta per la pace e la comprensione universale consisteva nella creazione di un linguaggio privo delle incertezze delle lingue naturali e basato sul metodo ipotetico-deduttivo delle matematiche.
In quegli anni travagliati dall’intolleranza e dalla violenza – nel 1648 si era conclusa la guerra dei Trent’anni, uno dei conflitti più sanguinosi dell’intera storia europea – cominciava ad affacciarsi l’ipotesi di un diritto internazionale in grado di mantenere la pace. Il linguaggio universale di Leibniz veniva incontro anche a tale esigenza, appianando, almeno in teoria, i bizantinismi e le ambiguità di cui il linguaggio delle relazioni estere era impregnato. Del resto, cosa vi è di più chiaro dei numeri? Leibniz, animato da un ideale antico, coltivato da altri prima di lui (Raimondo Lullo e Giordano Bruno), ma non in modo altrettanto rigoroso, aspirava a un linguaggio che potesse essere impiegato non solo per determinare la validità dei ragionamenti ma anche per acquisire conoscenze nuove. Era necessaria una macchina.
All’epoca, com’è facile immaginare, non esistevano quelli che oggi chiameremmo calcolatori. La cosa che più si avvicinava a una calcolatrice automatica era la pascalina, progettata nel 1642 da Blaise Pascal, che però era in grado di eseguire solo addizioni e sottrazioni. A tal fine – era il 1671 –, Leibniz progettò la sua macchina aritmetica in grado di effettuare le quattro operazioni aritmetiche elementari. La macchina funzionava grazie a quella che poi sarebbe stata chiamata la «ruota di Leibniz», un meccanismo dotato di denti di lunghezza crescente che fino al ‘900 è stato usato nelle macchine calcolatrici. Questa invenzione gli permise di essere ammesso alla Royal Society nel 1673, il maggior riconoscimento scientifico dell’epoca. Ma una macchina di per sé non è sufficiente.
Per fornire al suo calcolatore un linguaggio elaborò un sistema di numerazione binario, attualmente in uso in informatica, e una serie di istruzioni in modo che potesse funzionare automaticamente – dimostrando di aver intuito il concetto di programmazione. La mente però corre più veloce della tecnica e sebbene Leibniz abbia continuato per tutta la vita a perfezionare la sua macchina, non fu mai in grado di renderla adatta alle operazioni nel sistema binario, per il numero troppo elevato di cilindri necessari al suo funzionamento.
Oltre al tedesco, sua lingua nativa, Leibniz conosceva il latino, il greco, il francese e l’italiano. Dalla sua familiarità con le lingue, Leibniz, anticipando Von Humboldt, aveva tratto la convinzione che alla base degli idiomi esistenti ci fosse una lingua madre originaria. L’idea di un linguaggio simbolico non era, pertanto, una fantasticheria futurista ma un ritorno al passato prebabelico dell’umanità, un ritorno a quell’armonia che è sempre stata al centro del suo pensiero e della sua azione politica.
Nella terminologia di Leibniz una caratteristica è un sistema simbolico in cui ogni simbolo rappresenta un’idea, e dotato di regole di manipolazione specifiche. Che una lingua del genere fosse possibile lo dimostrava non l’immaginazione ma la realtà stessa. La complessità del Cinese era un esempio in tal senso. La scrittura cinese è composta da caratteri di vario tipo: ideogrammi, pittogrammi, composti fonetici e composti logici. Sono questi ultimi, in particolare, a illustrare l’idea alla base della caratteristica universale di Leibniz. Così, ad esempio, per indicare il termine «casa» (jiā) si usa il simbolo 家 che è composto dall’immagine stilizzata di un maiale (豕) sotto a un tetto (宀). Segni intercambiabili, come i caratteri di una macchina stampatrice, in grado di rappresentare con chiarezza e completezza l’universo dei pensieri umani.
Il presupposto da cui partiva Leibniz, la possibilità di elaborare un linguaggio formale completo, si è scontrato nel Novecento con il teorema dell’incompletezza di Gödel, che ha dimostrato come ogni teoria logica, e di conseguenza ogni scienza, si fondi necessariamente su una serie di proposizioni indimostrabili.
Ciononostante l’idea di un linguaggio universale continua a esercitare un fascino profondo. Nel tempo gli orizzonti della matematica si sono ampliati e sono state proposte nuove fondamenta (si pensi all’algebra astratta o alla teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel), e l’avvento dei computer ha portato a nuove applicazioni della logica formale, dando maggiore importanza al suo linguaggio. Ne sono un esempio quei software in grado di stabilire se un teorema sia dimostrabile o meno, svilupparne e controllarne i passaggi logici. Ma la perfezione non è nemmeno delle macchine, figlie anch’esse dell’uomo, e può accadere che alcuni passaggi mostrati in output, nonostante la loro correttezza, risultino a noi inintelligibili. È quindi naturale chiedersi se un linguaggio universale sia non solo realizzabile ma persino auspicabile.
L’immensa, forse insormontabile, difficoltà riscontrata nel tentativo di prevedere il mondo può apparire sconfortante, ma è forse proprio grazie all’impossibilità di creare un linguaggio universale che il mondo è quel che è. Fenomeni complessi come la vita e il pensiero richiedono sistemi fisici altrettanto complessi. D’altro canto, un sistema puramente caotico in cui le particelle si comportano in maniera del tutto casuale non costituirebbe un ambiente adatto alla vita. L’essere umano si trova allora a metà tra questi due estremi, da un lato l’assoluta semplicità vagheggiata ma irrealizzabile; dall’altra una casualità altrettanto assoluta, che renderebbe impossibile qualsiasi descrizione completa. È proprio questo trovarsi nel mezzo tra la regolarità e l’imprevedibilità che fa della scienza, dell’etica e del pensiero ciò che sono.
La «caratteristica universale» rimarrà probabilmente poco più di un sogno, ma comprendere le cause della sua irrealizzabilità può farci acquisire consapevolezza dei nostri limiti epistemologici ma al tempo stesso della forza di cui siamo capaci, se abbiamo il coraggio di usarla. Leibniz paragonava la mente di Dio a un’immensa biblioteca colma di tutti i libri mai scritti e di quelli non scritti. Al suo interno, tra ciclopici scaffali e volumi interminabili doveva senz’altro trovarsi il libro scritto da Dio stesso, contenente tutti i destini del mondo; il libro in cui ogni singola parola rimandava alla descrizione completa dell’ente che denotava.
Forse un libro del genere non è mai stato pensato per l’uomo.