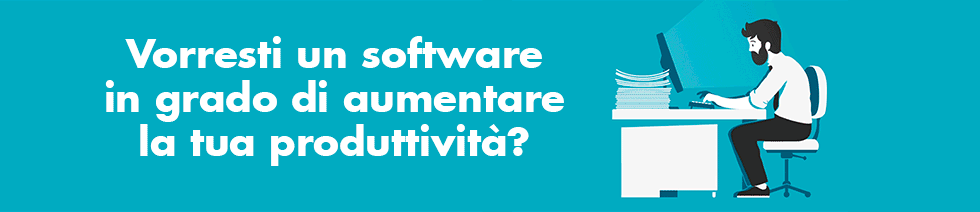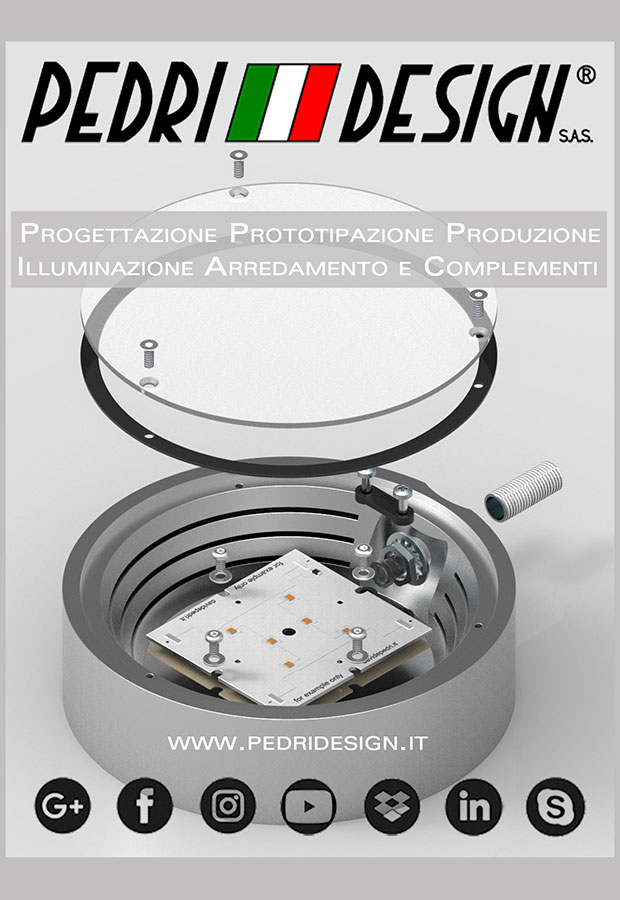Quante volte, dopo una disavventura o una vicenda sfortunata, ci viene detto dagli altri o dalla voce nella nostra testa “c’è chi sta peggio”? Quella frase, confortatrice di animi, si nasconde sotto un sottile velo di ipocrisia, perché, parliamoci chiaro, chi di noi si preoccupa realmente di chi si trova al di fuori della propria nicchia? Il nostro protagonista, con perfida decisione, aveva rimosso il velo di falsità che aleggia sull’enunciazione e, poveruomo, se ne faceva un vanto. Era caduto da ormai qualche anno nella morsa della routine, che, poco a poco, lo stava dilaniando, senza che lui se ne rendesse conto, così come il tarlo mangia il legno. Si alzava la mattina e, dopo una rapida colazione, andava in bagno per radersi la barba prima di andare a lavorare. Dopo aver disposto la schiuma per la rasatura, impugnò il rasoio e lo avvicinò al lato destro del suo viso, avendo ben cura di evitare il neo che risaltava, seppur di poco, vicino il collo. Ah, quanto lo odiava. Quel foruncolo rappresentava la sua unica imperfezione, almeno a livello visivo. Avrebbe fatto di tutto per eliminarlo, ma ormai, a quell’età, era divenuta una sua proprietà intrinseca. Pensò di averne abbastanza. Era stanco di fingere la sua sopportazione.
Il fatto che più detestava era che, a detta sua, l’impercettibile ombra generata dal rilievo andasse ad oscurare i suoi pregi. Gli capitava spesso di immedesimarsi nella vista altrui e lo logorava il pensiero che il primo colore bruno ad essere notato non fosse magari quello dei suoi capelli, o, forse, quello dei suoi occhi, bensì quello della macchia. Eppure, questa sua mania non era così recente, ma si era manifestata nel tempo. Aveva provato a scongiurare il tormento datogli dal difetto, colorandosi di un biondo ramato la chioma, come per spostare l’attenzione altrove, ma, una volta faccia a faccia con il suo riflesso, assumeva quasi naturalmente un’inclinazione di quei pochi gradi che gli permettevano di osservare il nemico. Provò allora a rasarsi, ma il risultato restò immutato. Eppure, scavando a fondo nella sua ossessione, essa non nasceva da altri che, con frasi più o meno amichevole, avrebbero potuto sottolineare la presenza della sua impurità. Il virus lo aveva insinuato lui stesso, giorno dopo giorno.
Il suo sguardo, che con l’avanzare delle primavere aveva mutato il suo castano acceso in una variante meno espressiva del colore, era continuamente trafitto dall’orrida visione. Si accorse che la crema iniziava a seccarsi e si trovò costretto ad abbandonare ogni qual si voglia pensiero per passare all’azione. Aveva già in mente cosa raccontare ai conoscenti se il suo impeto di follia fosse finito male. Pensando che, alla peggio, avrebbe avuto una ferita, poteva giustificarla con il classico taglio da lametta dopo uno scatto incontrollato della mano. Non era uno sprovveduto. Erano giorni che la sua assillata mente escogitava tutto nei minimi dettagli. Difficilmente qualcuno lo avrebbe fermato: abitava da solo. Non si era mai sposato e non aveva figli, perché vedeva nel matrimonio solo una prolunga della forbice dell’abitudine, che già lo stava erodendo, così come l’acqua sbriciola il masso: lentamente, ma senza tregua. Eppure, in certi momenti, aver avuto una persona con cui condividere gioie e dolori non gli avrebbe provocato disgusto.
Era molto avaro e geloso delle sue vittorie e credeva che doverle vivere assieme a qualcun altro contribuisse solo a smorzare la sua gloria. Ma, di tanto in tanto, si concentrava immaginandosi al fianco della sua ipotetica amata, rimanendo stupito di come un fugace brivido lungo la schiena gli facesse capire che i cari, anziché dividere, avrebbero amplificato le sue emozioni. Ma non era un uomo fatto per i rimpianti. Certo, alcune mancanze lo avrebbero potuto rendere realmente felice. Ma anche su questo, aveva una sua visione. Cos’è la felicità se non un’invenzione umana? Non vi è certezza che gli animali o le piante siano al corrente della sua esistenza e nel piano primordiale di Madre Natura, essa non era prevista.
Quindi, cos’è la felicità senza la vita umana? Eppure, credo sia anche giusto porsi la domanda opposta e complementare: cos’è la vita umana senza la felicità? Ma l’alta dose di orgoglio e narcisismo che gli scorrevano nelle vene lo spingevano a non osservarsi mai come colpevole. D’altronde, se tutte le fidanzate che lo avevano affiancato non erano rimaste, che colpa ne aveva lui? Era sempre la parte lesa tra le due ed assumeva il ruolo con una disarmante naturalezza. Ma, se al primo posto nei suoi pensieri vi era la chiazza marrone a nord ovest del suo mento, sul secondo gradino del podio si accomodava, relativamente fiera del piazzamento, la sua solitudine. Era una nave al largo: sai che c’è. Magari non sai dove di preciso, ma sei certo che il mare sta bagnando il legno con il quale è costruita.
Durante le giornate soleggiate non si fa vedere, ma durante la tempesta resta al molo ed, una volta lì, non puoi fare altro che notarla. L’opzione di un percorso psicoanalitico non la prese nemmeno in considerazione: avrebbe ammaccato eccessivamente la sua immagine di uomo di ferro, ma non tanto per gli sguardi altrui, bensì per il suo. Combatteva la lacuna di rapporti affettivi leggendo e studiando, perché era a conoscenza dell’importanza di avere una cultura di prim’ordine. Eppure, anche qui, osservando le reali ragioni alla base di ciò, il suo unico intento era quello dell’autocompiacimento, visto che dell’opinione altrui se ne faceva di poco. Ma il tempo passato sopra i testi era come colla sui cocci di un vaso frantumato. L’effetto era poco duraturo ed i frammenti ogni volta diventavano più minuti, ogni volta più complicati da unire nuovamente. E sotto quella corazza di amor proprio, il nostro soggetto si sentiva esattamente così: nient’altro che un contenitore distrutto. Ed era forse per questo che non riusciva a provare empatia nei confronti di nessuno. E qui si torna al principio.
Non voleva più sminuire le sue disgrazie soltanto perché magari un soggetto casuale, in un logo sperduto, per motivi a lui sconosciuti, ne ha di più grandi da affrontare. Provò durante qualche episodio a sforzarsi nell’esercizio, ma l’unico effetto sortito fu una risata contornata dalla ormai abituale convinzione di essere martire dell’evento. La prima volta che si confrontò con tale circostanza fu quando si trovò all’ospedale, con una mano interamente fasciata, che avevano assorbito il colore ramato dalle ferite. In seguito ad un’accesa discussione, sfociata poi in un’accesa litigata, la sua ultima ragazza uscì dalla sua casa, giurando di non rimetterci mai più piede. Seguì un attimo di realizzazione del tutto. Dopo un profondo respiro, decise che la cosa migliore fosse lasciar correre e, magari, calmarsi con una sigaretta e del buon rum cubano. Fece ripartire il giradischi che aveva interrotto il suo canto, perché il vinile inserito era giunto al termine dopodiché si accomodò al suo posto.
Ad un certo punto, in contemporanea al momento in cui la canzone arrivò al suo picco, ebbe uno scatto d’ira, come se il tappo che bloccava le sue emozioni fosse saltato, rovesciando la sua frustrazione, diluita nella rabbia, ovunque. Si mise ad urlare maledicendo sé stesso e la sua ormai vecchia compagna e, con tremenda forza, sferrò un pugno dall’alto rivolto al tavolo, frantumando il vetro che conteneva la bevuta. Si accorse solo qualche attimo dopo che la sua camicia era macchiata di sangue e, con un’occhiata fulminea, notò il suo arto gocciolante. Dopo qualche vano tentativo di rimozione delle schegge di cristallo, decise che la cosa migliore da farsi fosse presentarsi al pronto soccorso, cercando di trattenersi il meno possibile, evitando irritanti domande sull’avvenuto, del quale, a mente lucida, iniziava a vergognarsi. Arrivato dinnanzi allo specchio nei pressi della porta, osservò la sua sagoma svuotata di ogni sentimento, dalla carnagione candida e luccicante per il sudore.
Raddrizzò il papillon, sistemò la giacca, avendo cura di abbottonarsi nei punti strategici che gli avrebbero permesso di occultare la vista delle zone macchiate di rosso e, fissandosi negli occhi, rivolse al suo doppio le famose parole. “C’è chi sta peggio”. Ma si accorse, nell’istante seguente alla fine della pronuncia che la stazione era invariata. Cercando di evitare di scomporsi una seconda volta, sempre rivolgendosi al suo riflesso, disse “Permettimi un’osservazione. Dopo quel che hai detto, Lei è tornata indietro? Il sanguinamento ed il dolore si sono interrotti? No. Allora a cosa è servito dirlo? A sminuirmi? Io sto vivendo la mia situazione, ed in questo momento, detto tra noi due, quale rilievo ha il fatto che sulla faccia del pianeta vi è chi soffre maggiormente? Il dolore è soggettivo. Solo io so cosa provo e gli altri non devono permettersi di giudicare. Quindi, caro mio, la prossima volta fammi il piacere di evitare. Una volta concluso il suo inusuale monologo, non riuscì a resistere all’impulso del suo sguardo di far tappa sul neo.
Si domandò se ci fosse sempre stato, dato che prima non ne aveva mai notata la presenza. Ma in quel momento non gli dette molto peso, e si trascinò a farsi medicare. Aprì nuovamente il rubinetto e si sciacquò il volto, rimuovendo la crema secca e spargendone di nuova. Era stranamente nervoso. Tutti quei ricordi che uscivano dalla fontana della memoria lo stavano mettendo dinnanzi alla trama del film della sua vita, e lui ne era fortemente terrorizzato. Nell’ultimo periodo non usciva più di casa. Camminando per strada, si riguardava dall’avere incontri e se ne stava accostato al muro. Capì di preferire le pareti domestiche quando lui stesso, che aveva condotto un’esistenza finalizzata alla venerazione della sua figura, notata la sua ombra, si vergognò di sporcare la città con essa. Non provava più sapore nell’acculturarsi, né nel lavoro, né in quei pochi rapporti umani che poteva avere. Era come se, inseguito a quella notte di ricovero, si sentisse viscido e privo di anima ad aver condotto quella sua riflessione. Come se avesse visto davvero chi soffriva più di lui.
Si sentiva squarciato dall’interno dal disagio e schiacciato dal peso della sua riscoperta coscienza. Gli tremava l’intero braccio. Una volta accostato il rasoio al suo antagonista, iniziò ad essere assalito da dubbi, che lo incanalavano verso una sola ed inevitabile domanda: “Sono stato una brava persona?”. E ciò che lo massacrava non era più la macchia, ma la risposta che chiunque avrebbe potuto dargli. Crebbe in lui il seme dell’esito negativo al quesito. Il suo ondeggiare si intensificò e, guardandosi nelle orbite, si chiese “Tu che dici?”. Non esternò la risposta. Si asciugò le prime lacrime della sua vita, fermò il suo tremolio e, con un profondo respiro, spostò la traiettoria della lama poco più sotto rispetto al neo, e disse “vediamo se c’è ancora chi sta peggio”.