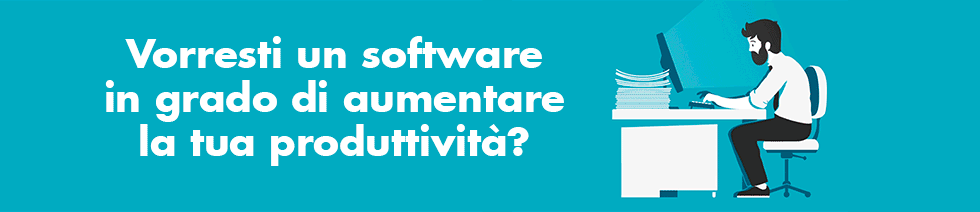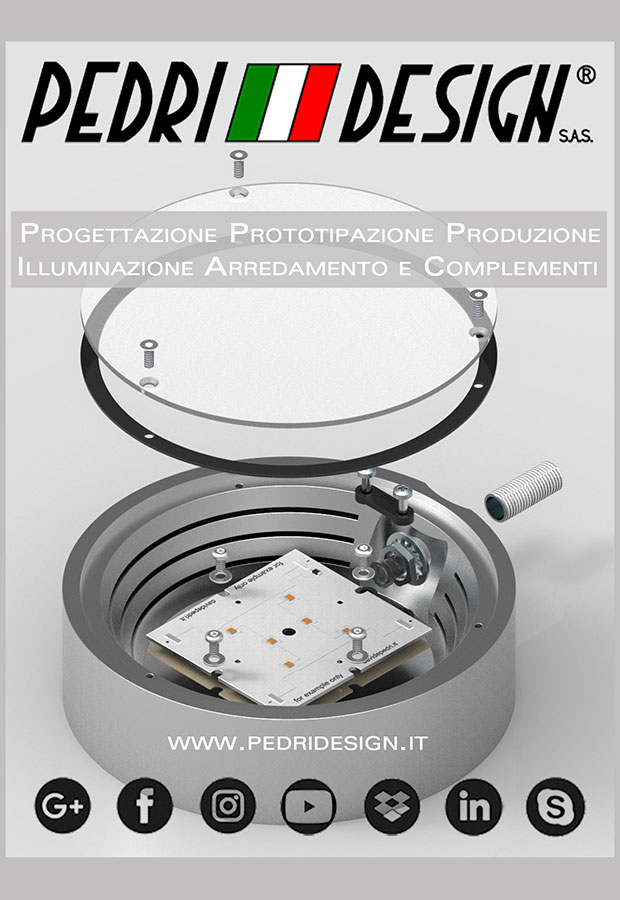In questi ultimi, miserrimi tempi, paragonabili – con audacia – all’Alto Medioevo, sembra siano ripresi, moderatamente, gli spostamenti ed i viaggi attraverso le vecchie strade tracciate dai pellegrini, alla ricerca di una vita che li accostasse ad uno Spirito Superiore. Era la Fede, allora, che muoveva – oltre ai commerci – uomini semplici ed ingenui a superare ostacoli ed a sfidare l’ignoto con coraggio e determinazione. Il premio? Raggiungere la mèta dopo giorni, mesi a volte, pieni di privazioni e sacrifici, pagati con la gioia e l’entusiasmo di sentirsi, in piccolissima parte, vicini alla Pace ed alla Serenità. Niente di tutto questo, oggi, per gran parte dell’umanità. La nostra esistenza è ormai impregnata di superficialità ed apparenza perché siamo noi stessi che ci autocelebriamo per aver raggiunto vette di capacità tecniche che c’infondono un’autostima che va oltre una ragionevole bravura. Non si viaggia più per motivi spirituali; ora, si viaggia nello spazio, senza ostacoli né stanchezza fisica, e le strade servono per le automobili, magari intelligenti tanto da non doverle guidare; diventeranno tutti ignoranti? Sono rimasto indietro, mi dicono troppo spesso, tanto da farmi sentire “obsoleto”, una parolaccia che sta per antico, sorpassato, inutile.
Che ci posso fare? Niente, e niente farò finchè le gambe reggeranno e la testa riuscirà ad essermi complice perché la vita va vissuta, e giocata, con le proprie capacità e con pochissimi aiuti artificiali. Sto con il grande Totò quando declamava: “Ma mi faccia il piacere!”. Io resisterò, nonostante qualcuno abbia riscoperto un’altra parola ripescata chissà dove e perché: “resilienza”, e questo sarebbe l’Italiano del domani? Questo preambolo, un po’ lungo, per precisare, ancora una volta che io preferisco vedere con i miei occhi che guardare l’orgia di colori, di parole, di visioni che regalano la TV e gli ultimi cellulari, carissimi. Camminare, guardare, mettere da parte, e rivivere il tutto: un lungo, felice commovente pellegrinaggio con i miei ricordi, che non sono eccezionali, ma tesoro inestimabile che nessuno mi potrà mai togliere, mai. Si sa, invecchiando riaffiorano, come per magìa, episodi lontani, anche di decenni, che avevi messo da parte e credevi perduti. E’ una regola, da sempre; c’è chi, addirittura trova più facile ricordare il passato remoto che quello prossimo; sembra un controsenso, ma anche a me sono capitati fatti del genere.
Un nome, una località, un avvenimento: in questi tempi, dominati dalla concitazione del presente, è più facile che la memoria arretri verso momenti che hanno scritto la tua storia, e che sono rimasti dentro perché si legano a qualcosa di speciale se non unico.
Rimembranze, però, molto difficili per ciò che riguarda i volti; spesso, ultimamente, dando un’occhiata distratta e svogliata allo specchio, mi chiedo: ma, sono io quello? Alcuni amici mi dicono: nono sei cambiato. Col cavolo nero, rispondo a me stesso! Correre, non corro più; mangiare, sono vicinissimo al brodino serale, puah! Non fumo più: dicono, meglio. E potrei continuare con ahimè e ohibò. In questo crepuscolo di persona normale, cosa mi può riscaldare di più se non la vita passata? Sono tra gli ultimi che ricordano i vecchi, tutti e tutte, vestiti di nero (spesso dopo un lutto), parcheggiati in un angolo del camino, che si ravvivavano solo quando un nipote chiedeva della loro gioventù. Ora ci sono i termosifoni, e i vecchi… Insomma, viene questo tempo per tutti, fino all’impegno inderogabile e inflessibile. Così, anche il mio passato comincia come tutti i pellegrinaggi: una partenza, uno svolgimento, più o meno lungo (dipende da quanto la vita sia stata frenetica o meno) e una mèta, che rimane ancora avvolta nella nebbia. Nel mio caso, il più remoto è datato dall’Elsa. Che dolcissima memoria! Nato per caso a Colle perché lì vi abitava la famiglia materna, trasferitisi nell’immediato dopoguerra del ’15-’18, ed io là fui “parcheggiato” d’estate, dopo che i miei aprirono un bar a Collodi. Solo a scriverlo, tutto si ravviva in me; in realtà, fu la prima tappa che dette inizio alle altre. E fu proprio lì che cominciai ad allenarmi affinchè la solitudine mi fosse amica, e mi accompagnasse da allora. Ricordo abbastanza bene volti e luoghi che mi resero felice; i nonni e gli zii (sei!), giovani allora, tutti intorno a me: ero il primo nipote, e l’affetto fu forte, tanto.
Era da poco finito il mestiere del “treccone”, che aveva impegnato per qualche anno nonno Anchise. Un ciuchino (Marco) ed un piccolo barroccio, carico del necessario per soddisfare le esigenze delle famiglie isolate che vivevano nel circondario, ma lontano dal mercato. Filo per cucire, aghi, piccoli utensili, biancheria, bicchieri e piatti … Tutto è finito, sepolto: il mondo della campagna com’era fino alla metà del secolo scorso. Storicamente, Colle fu teatro, l’11 giugno del 1269, di un’altra battaglia tra Siena e Firenze, con quest’ultima vincitrice, e che scancellò la sconfitta di Montaperti. Nonostante ciò, i colligiani rimasero, come da prima, nell’orbita senese. La cittadina si presenta su tre piani. Colle Alta, quella medievale, ancora ben conservata, da visitare; Colle Bassa o il Piano, più sotto di circa 200 m, la parte moderna, quella industriale, con le cartiere, il cristallo, i cavallucci e, nel passato, la lavorazione del marmo. Di rilievo artistico, Piazza Arnolfo di Cambio, qui nato come il pittore Cennino Cennini; la sua opera maggiore, Palazzo Vecchio. La chiesa di S. Agostino, e una chiesina, S. Maria a Spugna del X secolo. Inoltre, la stazioncina ferroviaria, citata da Carlo Cassola nel suo romanzo “La ragazza di Bube”, e il campo di calcio, chiuso da due poggiate e due enormi platani. Le squadre entravano da un sotto passaggio e, sbucando, avevano l’impressione di giocare in un piccolo Colosseo. Per finire l’argomento economico, il maggior traino era quello dato da “babbo Monte”. Dopo la nascita, quando ritornai a Colle verso la metà degli anni cinquanta, i nonni abitavano in un appartamentino proprio in via Spugna, a 20 m. da quella chiesina, e dormivo su materasso di foglie di granturco. Più in basso, c’era un fabbro ferraio: quante martellate, tutti i giorni! Eppure, nonostante questo, quando sei piccolino, dormi col granturco e il martello. C’era, proprio lì, un piccolo universo, un po’ distante dal centro, e dove feci le prime conoscenze dei ragazzetti che vi abitavano. Compagni allora cari, che oggi ho completamente dimenticato, purtroppo.

Dal terrazzino dei nonni, si vedeva, giù in basso, l’Elsa, intesa non come impugnatura della spada, ma il fiume che costeggia, 100 m. più in basso, la cittadina: il terzo elemento. Ecco come è nato il toponimo: Colle di Val d’Elsa. E proprio lì, nel fiume, ho trascorso mattinate e pomeriggi che mi hanno accompagnato quasi tutti i giorni con il suo lento scorrere estivo per il salto di un pesciolino, per il silenzio interrotto da un cinguettìo, per il profumo di quella libertà totale, che poi ritroverò in poche, memorabili occasioni. Un curioso, e indimenticato episodio. Le cartiere, impiantate nei secoli XI e XII, per la loro manutenzione, fermavano la produzione una settimana l’anno. In questa occasione, fui invitato dai ragazzi che gravitavano in via di Spugna, a partecipare ad un pésca eccezionale. Sotto il suolo della cittadina c’era, e c’è ancora, un reticolo di gore collegate al fiume. Nel momento in cui le fabbriche si fermavano, nel percorso di queste, in diversi punti così agevoli tanto da poter camminare eretti, si formavano dei bozzi. Per questo, la pésca, simile ad una tonnara, si faceva a mano o con un retino per farfalle, insieme ai secchi. Sì, perché non ho più assistito ad un fatto come questo. Nelle pozzanghere che si erano formate dopo un giorno dalla chiusura, i pesci – intrappolati – erano decine e decine: impressionante! Dopo 2-3 giorni queste battute, la nonna non ne voleva più sapere di friggere, e anch’io ero abbastanza sazio. Così scorreva l’estate, ritmata dal martello del fabbro, dalla pésca nell’Elsa, dalla visita agli zii, dalla partita di calcio col nonno, e dalle zucche vuote (ce n’erano di campi!), illuminate dall’interno da candele, altro che Halloween: queste erano tagliate da noi, ognuna diversa dall’altra, e suscitavano gioia e curiosità. Altri tempi.
Poi, tornai, una decina d’anni dopo. Fu mio zio Uili che mi spinse a farlo, per un torneo notturno di calcio tra bar e frazioni comunali, quando la passione per queste gare era forte. Non sfigurai, mi fu detto, per la felicità dei miei, nonna e Pan Pepato, anche se, appena finita la partita, tornavo a casa, e la strada era abbastanza lunga. Questa fu l’ultima “riunione di famiglia”. Il declino, inarrestabile, era cominciato, e somigliava al romanzo di Giovanni Verga “I Malavoglia”: una famiglia unita che, poco a poco, si disgregava e non si riconosceva più. Così la mia. Quelle estati da adolescente leggere, antiche, fragorose tra il materasso di foglie di granturco e il martellare del fabbro, erano finite. Rimaneva una piccola ma ricca felicità infantile che riappare, ora, all’imbrunire della vita, più lucente che mai. L’inizio sarebbe questo, quanto troverò in me la voglia di rivedere, e salutare, gran parte dei luoghi e degli edifici, anche se non ci sono più, o sono cambiati. Commozione e gioia si confonderanno, come da regola di questo gioco, magari riprendendo quel trenino … Ma la stazioncina non c’è più, e i binari ricoperti d’asfalto. Anche il campo di calcio è diventato un parcheggio a favore di uno stadio con tanto cemento e la pista d’atletica. Così s’innesta il dolore, già messo in conto, e per questo, forse meno profondo; una specie di rassegnazione che la pelle, ormai non più elastica, riesce a sopportare. E proprio nell’Elsa ho lasciato un bel “pezzo” del mio cuore: è sempre la prima volta che non muore mai. Ecco perché, sul finire, ti verrà detto che questo è stanco: i tanti “pezzettini” lasciati lungo la strada, alla fine, ti mancheranno.

E’ la prima tappa,, che io chiamo dell’Elsa, che mi fa, ancora, festa dentro, tanta. Ricordi semplici e modesti, come quella esperienza, con il tempo che scorreva lentamente tutto intorno. Poi, il passaggio dalla fanciullezza alla gioventù, che ha segnato, senza rumore, quell’addio, mascherato da arrivederci. Crescendo, la vita aveva preso un altro ritmo. Ancora qualche viaggio con la macchina, ma tutto – o quasi – era cambiato, e le assenze si facevano sempre più forti pur se silenziose, troppo. Diventavo grande, e avevo cominciato a mettere da parte le piccole emozioni che avevo vissuto per alcune estati. La distanza dall’Elsa sembrava si allungasse e quella, a volte, la dimenticavo. Se questo è l’inizio di un pellegrinaggio, dov’è nascosta la contentezza? Dove, il piacere di cercare di rivivere piccole gioie memorabili, scolpite dentro? Cosa farò, dunque? E si accende il conflitto tra il partire e il non farlo. Forse, non lo farò, e so già che mi mancherà, tantissimo. E’ la storia dell’uomo perché ogni decisione da prendere propone questo dilemma: è meglio versare qualche lacrima oggi, oppure piangere forte domani? L’Elsa continua a scorrere. L’appartamentino in cima a via di Spugna è chiuso, per sempre.