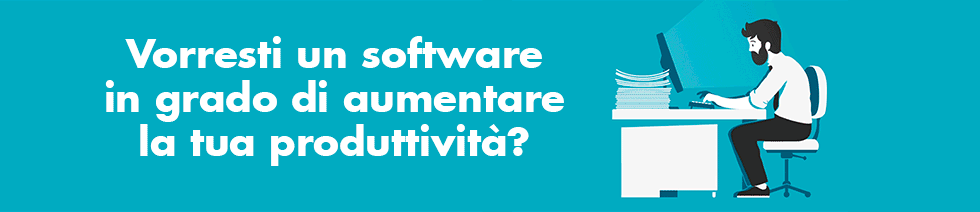Nel V sec. a.C. scoppiò un lungo conflitto in più fasi che oppose Sparta e Atene, e le rispettive coalizioni, per stabilire a chi spettasse l’egemonia sulla Grecia. L’opera che ne svela le dinamiche interne e le pieghe in cui la Storia nasconde i propri retroscena è “La guerra del Peloponneso” di Tucidide, scritta quando il corpo devastato e sofferente dell’Ellade era ancora caldo. Nel II libro vengono descritti i primi tre anni di guerra, e l’assedio alla rocca di Atene durante il quale la città viene colpita da un’epidemia che ne decima la popolazione, e in cui muoiono lo stesso Pericle e alcuni suoi familiari. Subito vengono individuati i responsabili, o meglio, i capri espiatori: serpeggia nelle strade la diceria che siano stati gli spartani ad avvelenare l’acqua potabile delle cisterne per mettere in ginocchio i cittadini assediati. Tucidide descrive minuziosamente i sintomi del male – probabilmente quelli di una febbre tifoidea aggravata dalle restrizioni imposte dalla guerra – e rileva come la diffusione del contagio sia irrefrenabile, a causa dei comportamenti della popolazione dettati dal panico: affluiscono in massa i contadini dalle campagne, e nei primi tempi, nonostante i richiami delle autorità cittadine, i rapporti reciproci si intensificano, nel tentativo di prestare cure ai parenti e agli amici ammalati. Solo in seguito, quando il morbo ha già decimato gli ateniesi e le strade sono piene di cadaveri che nessuno vuol seppellire, i malati vengono gettati nelle strade o lasciati a morire da soli nelle case. Gli argini della legalità e della morale vengono travolti: gli sciacalli entrano nelle case degli appestati per rubare, chi ha denaro lo sperpera in orge e baccanali nella convinzione di non avere più un futuro davanti, il godimento immediato diventa l’unico obiettivo perseguito da folle di persone che si ritrovano uguali nella morte. Cadono le barriere tra ricchi e poveri, aristocratici e plebei, politici e contadini: il morbo colpisce chiunquecolpisce , annulla nella morte le distinzioni sociali. E nel frattempo inizia il declino inesorabile dell’Attica, la carestia dilaga, la popolazione cala vertiginosamente: il mondo antico cambia volto per sempre. Nel II sec. d.C. l’impero romano deve fronteggiare, lungo i confini orientali, popolazioni di origine iranica e germanica, rispettivamente i Parti e i Marcomanni, che premono per varcare il limes, chiedendo protezione e terre da coltivare. Sono in fuga verso ovest, alle spalle popolazioni che scendono da nord e li spingono verso il Danubio. Fino a quel momento la politica romana è stata improntata alla chiusura dei confini e alla regolamentazione rigida dei flussi immigratori; in un mondo densamente popolato, con un’economia solida e segnali di declino che tardano ad essere decifrati, le frontiere costituiscono un baluardo invalicabile contro la barbarie. Nell’impero entrano, di fatto, solo i mercanti, e solo se muniti di speciali lasciapassare. La peste antonina che esplode proprio durante la guerra contro i Parti, attorno al 160 d.C., cambia tutto. Si tratta, probabilmente, di vaiolo, in base alla descrizione dei sintomi che ne fanno il medico Galeno e gli storici Cassio Dione e Ammiano Marcellino. L’esercito romano, di ritorno dalla campagna partica, lo diffonde nelle province che attraversa, spopolandole; le stime parlano di un’epidemia di durata trentennale, che causa la morte di milioni di persone. Il capro espiatorio, individuato dall’imperatore, è costituito dai cristiani, che non onorando gli dei romani ne hanno scatenato la collera. I sudditi si rifugiano allora nelle pratiche magiche, si affidano all’irrazionale e individuano le colpe della sciagura che li ha colpiti nel regno del soprannaturale, deresponsabilizzandosi; lo stesso imperatore Marco Aurelio, nei Colloqui con se stesso, scrive che la malattia è meno letale della menzogna, del comportamento malvagio e della mancanza di comprensione per i sofferenti. Nel frattempo, il mondo che i romani conoscono a poco a poco scompare. I commerci su carovana si fermano; i campi, abbandonati a se stessi, diventano sterili; i boschi si riappropriano dell’Europa, e scompaiono per secoli le centurie, le porzioni regolari e ordinate che contraddistinguevano l’agricoltura romana. Nell’arco di tre secoli gli imperatori saranno costretti a scendere a compromessi con i barbari, lasciando che si insedino entro i confini; hanno bisogno di contadini e di soldati, perché anche l’esercito è decimato, e molti Germani in questo modo avranno accesso ai quadri più alti delle carriere militari. In questi giorni di volontario, responsabile isolamento, ho letto molto. Ancora una volta mi sono resa conto che la storia si ripete, e che i comportamenti umani, nelle situazioni di crisi, seguono spesso direttive note. Non sono diversi i giovani che affollano i locali dei Navigli all’ora dell’aperitivo dagli ateniesi che sperperavano il proprio denaro in “piaceri che s’esaurissero in fretta, in soddisfazioni rapide e concrete”, come scriveva Tucidide; né lo sono quelli che rompono i blocchi imposti dalla quarantena, e viaggiano per centinaia di chilometri per tornare dalle famiglie, da quelli che entravano nelle case degli appestati per curarli e poi, magari, li abbandonavano al manifestarsi della malattia. Alla base, oggi come allora, ci sono una buona dose di ignoranza e la sottovalutazione degli effetti dei propri comportamenti, dettata da un egoismo personale diffuso, che mi turba profondamente. Se per la prima la cura c’è, dal momento che oggi le informazioni ci sono e sono facilmente reperibili, per l’egoismo non la trovo. Vedo le immagini delle persone accalcate ai concerti, o in fila per gli impianti sciistici, e penso che la Storia non ci ha mai insegnato un bel nulla, tantomeno l’idea che certi sacrifici, per il bene della comunità, siano necessari.
La peste antonina che esplode proprio durante la guerra contro i Parti, attorno al 160 d.C., cambia tutto. Si tratta, probabilmente, di vaiolo, in base alla descrizione dei sintomi che ne fanno il medico Galeno e gli storici Cassio Dione e Ammiano Marcellino. L’esercito romano, di ritorno dalla campagna partica, lo diffonde nelle province che attraversa, spopolandole; le stime parlano di un’epidemia di durata trentennale, che causa la morte di milioni di persone. Il capro espiatorio, individuato dall’imperatore, è costituito dai cristiani, che non onorando gli dei romani ne hanno scatenato la collera. I sudditi si rifugiano allora nelle pratiche magiche, si affidano all’irrazionale e individuano le colpe della sciagura che li ha colpiti nel regno del soprannaturale, deresponsabilizzandosi; lo stesso imperatore Marco Aurelio, nei Colloqui con se stesso, scrive che la malattia è meno letale della menzogna, del comportamento malvagio e della mancanza di comprensione per i sofferenti. Nel frattempo, il mondo che i romani conoscono a poco a poco scompare. I commerci su carovana si fermano; i campi, abbandonati a se stessi, diventano sterili; i boschi si riappropriano dell’Europa, e scompaiono per secoli le centurie, le porzioni regolari e ordinate che contraddistinguevano l’agricoltura romana. Nell’arco di tre secoli gli imperatori saranno costretti a scendere a compromessi con i barbari, lasciando che si insedino entro i confini; hanno bisogno di contadini e di soldati, perché anche l’esercito è decimato, e molti Germani in questo modo avranno accesso ai quadri più alti delle carriere militari. In questi giorni di volontario, responsabile isolamento, ho letto molto. Ancora una volta mi sono resa conto che la storia si ripete, e che i comportamenti umani, nelle situazioni di crisi, seguono spesso direttive note. Non sono diversi i giovani che affollano i locali dei Navigli all’ora dell’aperitivo dagli ateniesi che sperperavano il proprio denaro in “piaceri che s’esaurissero in fretta, in soddisfazioni rapide e concrete”, come scriveva Tucidide; né lo sono quelli che rompono i blocchi imposti dalla quarantena, e viaggiano per centinaia di chilometri per tornare dalle famiglie, da quelli che entravano nelle case degli appestati per curarli e poi, magari, li abbandonavano al manifestarsi della malattia. Alla base, oggi come allora, ci sono una buona dose di ignoranza e la sottovalutazione degli effetti dei propri comportamenti, dettata da un egoismo personale diffuso, che mi turba profondamente. Se per la prima la cura c’è, dal momento che oggi le informazioni ci sono e sono facilmente reperibili, per l’egoismo non la trovo. Vedo le immagini delle persone accalcate ai concerti, o in fila per gli impianti sciistici, e penso che la Storia non ci ha mai insegnato un bel nulla, tantomeno l’idea che certi sacrifici, per il bene della comunità, siano necessari.