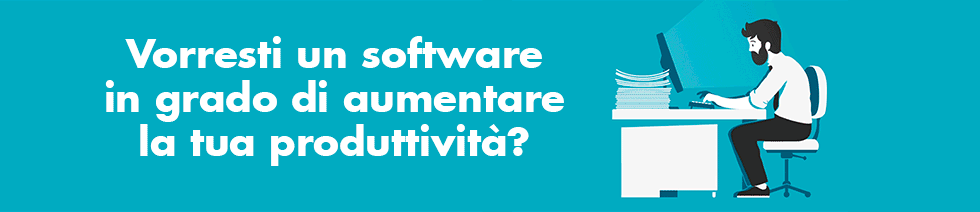A maggio di quest’anno i media hanno riportato le parole del presidente di Save the children, Claudio Tesauro, secondo il quale il 51% dei quindicenni italiani non sono in grado di decodificare un testo scritto. Il dato – da qualcuno definito una vera e propria bufala – è poi stato modificato al ribasso confrontandolo con quelli provenienti da altri istituti di controllo come l’OCSE o l’Invalsi, ma non ha mancato di suscitare polemiche e preoccupazione, anche perché è stato accompagnato dall’ulteriore nota che sono soprattutto le scuole del Meridione a incidere negativamente sulla media.
Quella che si chiama dispersione scolastica implicita a cui fa riferimento Tesauro, ovvero la percentuale di studenti che terminano il loro percorso scolastico senza aver acquisito le competenze fondamentali in nessuna delle tre materie monitorate dalle Invalsi (Italiano, Matematica e Inglese), è comunque alta, e non va sottovalutata; non a caso, il Pnrr ha stanziato un miliardo e mezzo di euro per combatterla e per risolvere il problema dei divari territoriali. Nelle prove invalsi di quest’anno tuttavia è stato rilevato che la dispersione implicita ha subito una lieve flessione, diminuendo dal 9.8 al 9.7% rispetto all’anno 2021 (in pratica uno studente su dieci ha risultati mediocri nelle tre prove); è un dato incoraggiante, causato anche dall’uscita dalla pandemia e dagli investimenti che negli ultimi anni sono stati fatti in tutti gli ordini di scuola.
Tuttavia emerge che sono sempre gli studenti provenienti dalle famiglie più svantaggiate da un punto di vista socioeconomico, o che vivono in aree depresse del paese, a registrare i risultati più bassi, e questo è un problema a cui la scuola non riesce a far fronte nonostante gli sforzi, perché richiede interventi organici e forze in campo molto più ampie.
Ritengo tuttavia che misurare i risultati scolastici tramite prove standardizzate o sondaggi su campioni di studenti sia sempre un’operazione pericolosa e falsante, per vari motivi. I ragazzi (tranne forse quelli di quinta superiore che si preparano per l’Esame di Stato) spesso affrontano le Invalsi in modo svogliato, o addirittura le boicottano fornendo risposte casuali; sanno che non danno luogo a una valutazione, quindi spesso non si impegnano nello svolgerle. Le Invalsi o analoghi strumenti di valutazione sono poi prove totalmente o in parte diverse da quelle che si usano nella didattica scolastica, perché propongono soprattutto esercizi a scelta multipla, poco amati da quasi tutti i docenti, che invece adottano parametri molto più complessi per monitorare l’apprendimento. Insomma, si capisce la necessità di disporre di dati su tutto il territorio nazionale ricorrendo a prove uniformi ma poi bisognerebbe andare a vedere cosa accade davvero nelle singole realtà.
C’è poi da sottolineare che la scuola, come sempre, genera luoghi comuni e vere e proprie falsità in chi non la vive dall’interno, e che è sempre facile associare il peggioramento della qualità degli apprendimenti a un generale peggioramento della qualità dell’insegnamento, che deresponsabilizza le altre agenzie formative, in primo luogo la famiglia, e gli studenti stessi. Insomma, se gli studenti non capiscono un testo, non sanno risolvere un problema di matematica o un esercizio di inglese la colpa non può che essere degli insegnanti. La verità è che spesso sono proprio gli studenti, per primi, a considerare la scuola e la formazione come inutili, se non a disprezzarle (per poi pentirsene amaramente vent’anni dopo…), e a nulla valgono gli sforzi degli insegnanti o i tentativi di far loro cambiare idea.
Leggere diventa un’attività sempre più rara, e ne risente infatti il modo di esprimersi, sempre più appiattito verso un gergo basso e un vocabolario limitato; e la matematica viene considerata come una materia difficile e scoraggiante, scollegata dal mondo reale. Solo dell’Inglese in fondo si riconosce l’utilità, ma è ovvio che le carenze nell’Italiano determinano poi difficoltà nelle lingue straniere. I modelli alternativi che la società propone sembrano suggerire che la cultura non serva più, quando invece è il miglior investimento che si possa fare su se stessi; perché spesso non è la formazione il problema, bensì il mondo del lavoro che non premia adeguatamente chi ne acquisisce una. Per convincersene basta guardare quel che succede all’estero, dove i laureati italiani sono a capo di team di ricerca, o assumono incarichi di responsabilità già giovanissimi, retribuiti con lauti stipendi. Un giorno al loro posto potrebbero esserci i quindicenni di oggi: bisognerebbe far loro recuperare l’idea che studiare è bello, e che lo studio richiede fatica, ma che quella fatica potrebbe essere addirittura entusiasmante.
Stefania Berti