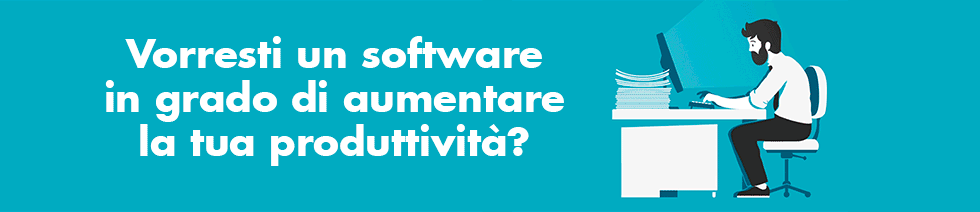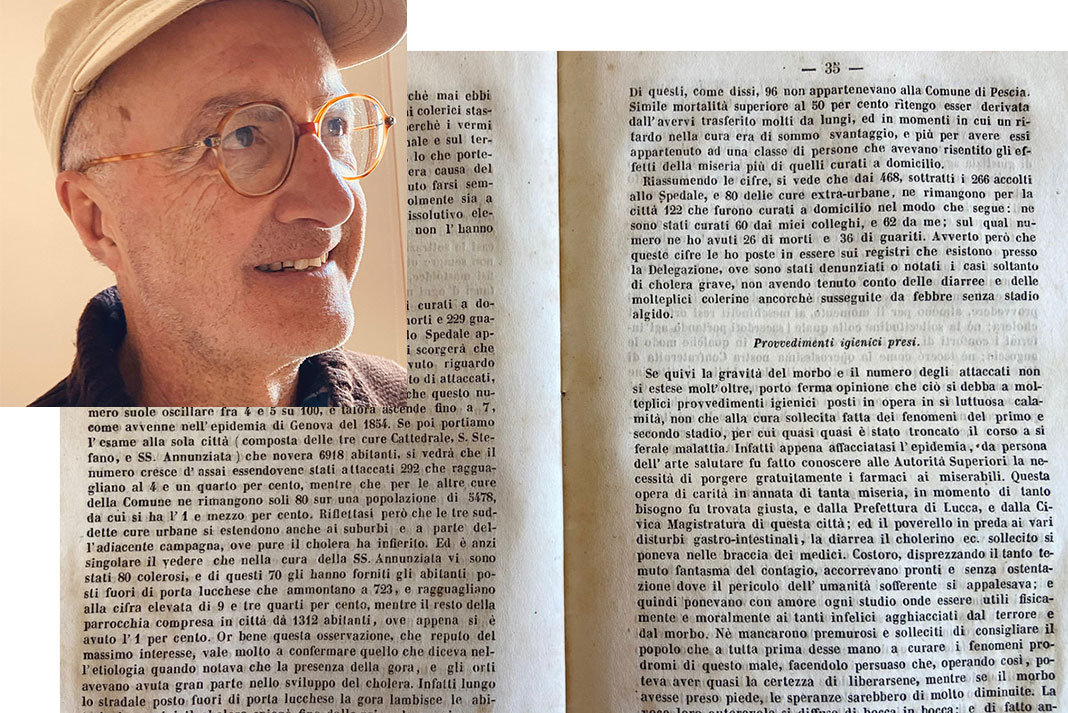La grave epidemia di colera del 1855 che colpì Pescia, così come la Toscana e gran parte dell’Italia, fu la terza delle sei epidemie che si manifestarono durante il secolo XIX. L’impatto sulla vita e sull’economia della nostra Comunità fu devastante e di certo favorito dalla scarsa igiene personale, dal sovraffollamento nelle case, dagli ambienti malsani in ambito lavorativo e domestico, dall’assenza di una rete fognaria e dall’utilizzo, in sua vece, delle gore cittadine.
La città di Pescia risultava, infatti, modellata nel tempo in rapporto ai “percorsi idrici” (le gore appunto) che non solo servivano ad irrigare gli orti presenti un tempo nel contesto urbano, ma erano utilizzati anche per le attività artigiane, per gli opifici andanti ad acqua e per i fabbisogni familiari.
La malattia era causata dal Vibrione, un microrganismo a forma di “S” scoperto nel 1854 nelle feci dei colerosi da Filippo Pacini, patologo pistoiese, e confermato 30 anni dopo dal batteriologo tedesco Robert Koch. Nonostante l’intuizione del Pacini si credeva ancora che il colera fosse una malattia non contagiosa, come affermava anche Maurizio Bufalini, “luminare” della Clinica Medica di Firenze. Inoltre si dava ancora credito alle teorie settecentesche che incolpavano di tale malattia il carattere delle persone e la “mancanza di allegria e di ilarità dello spirito” spingendosi a sostenere che “la paura favoriva il contagio”. Anche le anomalie metereologiche venivano credute la causa del colera, in particolare “il caldo nelle ore del mattino e la perfrigerazione in quelle serali”.
Il colera arrivava dall’India, dove si era propagato grazie alle acque del Gange che trasportavano anche feci umane e di animali (come accadeva peraltro nelle nostre gore).
Giunse in Toscana attraverso Nizza, Genova e il Piemonte. A Livorno fu il primo caso e, a dispetto di tutte le misure di quarantena, colpì dappertutto fino ad interessare Firenze.
La mortalità stimata in territorio italiano fu di circa il 50%. In Toscana dal luglio 1854 al gennaio 1855 si contarono ben 6512 casi con 3466 morti, senza considerare che la popolazione risultava già afflitta da altri pesanti problemi sanitari quali polmoniti, febbre tifoidea, carenze alimentari.
Nel caos totale che regnava nella nostra città, il dottor David Bartolozzi, nato a Lanciole e medico chirurgo condotto a Pescia, proprietario della Villa di Cafaggio, tra Monte a Pescia e Castello, si distinse subito per l’abilità nel porre le prime diagnosi di questa terribile malattia e nel consigliare la autorità locali sui comportamenti da adottare: isolare i malati, disinfettare le suppellettili, trattare con la calce le case degli infetti. Inviò molte lettere al Sindaco di Pescia, al Prefetto di Lucca e alla Commissione Sanità.
Nel suo volume “Osservazioni sul Cholera che ha regnato a Pescia nel 1855” il Bartolozzi esamina i casi specifici dei suoi ammalati, fornendo anche nome e cognome di questi, e descrivendo minuziosamente i disturbi di ognuno e il contesto familiare e ambientale, arrivando in tal modo a formulare un’ipotesi di lavoro.
Racconta anche che nello Spedale di Pescia furono ricoverati 468 ammalati nel luglio-agosto 1855, di cui circa la metà morirono. Inoltre almeno 300 sui 468 totali provenivano dai quartieri di Santo Stefano, Annunziata e Cattedrale, dove il reticolo delle gore era più sviluppato.
Il Bartolozzi pose l’attenzione sulle pessime condizioni igieniche delle abitazioni, sulle gore malsane, sulla promiscuità in cui viveva la maggior parte dei pesciatini, sui bassi salari dei lavoratori, sulle pessime condizioni igieniche delle fabbriche, delle strade pubbliche e negli orti (in particolare gli ortaggi erano concimati con materiale organico proveniente dai pozzi neri). Inoltre enfatizzò molto la mancanza di igiene delle acque potabili della città (fu in quell’occasione che donò alla cittadinanza una sorgente di Cafaggio proveniente dal Rio Bareglia, dopo che i Convalli, anch’essi di Cafaggio, nel 1700, l’avevano donata ai frati di Castello ai quali giungeva tramite l’acquedotto ancora ben visibile).
Il Bartolozzi aprì gli occhi alla classe politica inducendo pertanto una serie di riflessioni che avrebbero portato in seguito, dopo diversi anni, alla realizzazione di nuovi insediamenti abitativi e all’ammodernamento della città. Egli soleva ripetere con insistenza ai politici: “tante famiglie che vivono nelle Capanne e in via Vetturali abitano in veri tuguri ove manca anche il minimo dei requisiti igienici”.
Ovviamente le intuizioni del dottor Bartolozzi non andavano di pari passo con la terapia da lui praticata: non esistevano ancora gli antidiarroici, le soluzioni reidratanti o gli antibiotici ma nei casi sospetti venivano somministrati antielmintici, il tamarindo, clisteri di amido, limonate, laudano, ipecacuana, radica di calumba con oppio, unicloruro di mercurio, estratto di ratania, frizioni di alcool canforato. Lui stesso il 17 luglio di quell’anno si ammalò lievemente e fu curato dal collega ed amico dottor Filippo Desideri che gli consigliò il digiuno, la somministrazione di limonate e gli impiastri di semi di lino sull’addome.
Le parole del dottor Bartolozzi giunsero anche ai concittadini e alle Amministrazioni Comunali degli anni successivi e nel 1907 fu istituita una speciale commissione per creare una cooperativa di “case popolari ed economiche”. Ma solo l’amministrazione del Sindaco Bachechi negli anni ’20 riuscì a dare vita ad un nuovo quartiere a sud del centro storico detto San Michele, e edificò un fabbricato di case popolari con 12 quartieri in via Trento.
Bachechi realizzò poi anche la copertura di diversi gorili malsani. Il Podestà Ilio Romoli, nel 1931-32, pur con un notevole disavanzo finanziario, cercò di sviluppare la città a sud, nell’area di San Michele, per trasferirvi chi viveva in case malsane; rese fabbricativi i terreni agricoli recintati da alti muraglioni (l’Orto delle Suore di S. Michele, il parco Piacentini). Il Podestà Bernardo Fabbri (1935-39) fece costruire i Nuovi Gabinetti Pubblici in Piazza del Pesce, poiché i cantini erano usati come orinatoi; migliorò strade e illuminazione pubblica.
Credo che il dottor David Bartolozzi dovrebbe essere ricordato degnamente, magari intitolandogli una strada nella nostra città.