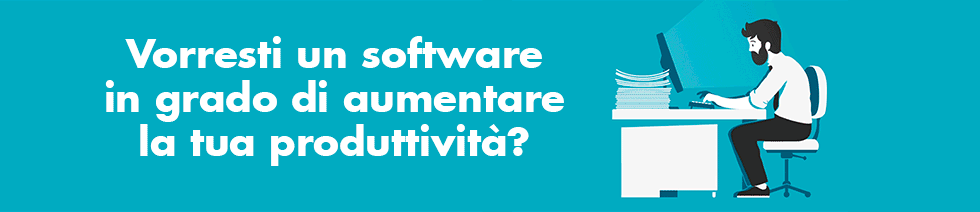La rabbia sociale che avvelena questi tempi, e che cerca continuamente capri espiatori per una situazione che in modi diversi ha messo a dura prova tutti, ha trovato un nuovo bersaglio, dopo gli untori che correvano sulle spiagge o nelle strade deserte delle città all’alba.
Lunedi è tornata a casa Silvia Romano, una ragazza milanese di venticinque anni partita diciotto mesi fa per lavorare con una Onlus in Kenya. Neolaureata in Mediazione Linguistica, con una tesi sulla tratta degli schiavi, ha lavorato come cooperante in progetti di sostegno all’infanzia, in una zona probabilmente non sicura, ma in cui fino a quel momento non si erano verificati episodi di violenza.
È stata rapita e portata in Somalia da un gruppo di terroristi legati a Al Shabaab, un’organizzazione jihadista che controlla parte del paese dal 2006. Liberata da un’azione congiunta dei servizi segreti italiani e turchi, e dietro pagamento di un riscatto, Silvia è arrivata in Italia l’11 maggio, e ha potuto riabbracciare i suoi familiari che forse l’avevano data per morta, forse non avevano mai perso le speranze: non lo sapremo mai con certezza e non è cosa che ci riguardi, quel che si agita nel cuore di un genitore che piange un figlio rapito nell’altro emisfero del mondo.
Non ha fatto in tempo a poggiare il piede sul suolo di Ciampino che i social si sono scatenati, e, a ruota, il giorno dopo, alcuni quotidiani: tra i titoli più vergognosi, come spesso succede, menzione speciale a “Il Giornale” di Sallusti (“Islamica e felice: Silvia l’ingrata”) e a “Libero” di Feltri (“Abbiamo liberato un’ingrata”). L’equazione terribile tra la religione che ha abbracciato e l’ingratitudine per i suoi liberatori, o peggio il terrorismo, è solo una delle cattiverie che sono circolate in questi giorni.
Di Silvia si è detto e scritto di tutto: è giovane, quindi è sicuramente una “sciacquina”, partita per l’Africa senza alcuna competenza tecnica, ma solo per scattarsi le fotografie coi bambini di pelle nera per poi pubblicarle sul suo profilo Facebook. Sorride, sembra felice; quindi sicuramente si è divertita, nei diciotto mesi da ostaggio. Se è stata violentata, le è certamente piaciuto; se l’hanno picchiata, in fondo se l’è cercata, perché doveva restarsene a casa. Se non è morta, è certamente colpevole di qualcosa. È vestita in abiti africani; è incinta, e quella cappa verde che le ingoffa i movimenti serve a coprirle la pancia; non ha il viso smunto, non appare sofferente, anzi sembra persino ingrassata; ha sposato uno dei suoi rapitori, e presto tornerà da lui che nel frattempo si è intascato il denaro del lauto riscatto che lo Stato ha pagato (quello a cui ognuno dei sessanta milioni di italiani attualmente viventi, neonati e ultracentenari compresi, ha contribuito con la cifra di 0.06 centesimi a testa).

E si è convertita, scegliendo un dio che in qualche modo oltraggia le coscienze di chi, dal divano del proprio salotto, l’ha vista tornare a casa. “Vi sareste convertiti anche voi, nella sua situazione”, si è sentito anche questo: ma quella che voleva essere una difesa si è trasformata in un’altra velata accusa. Come se una conversione all’Islam fosse in qualche modo legata a una minaccia, a una costrizione, e non l’atto libero e volontario di una persona, padrona di sé, che sceglie a chi rivolgere le sue preghiere.
La sintesi migliore delle reazioni suscitate dal ritorno di Silvia Romano l’ha data Daniele Luttazzi, due giorni fa, sul “Fatto Quotidiano”: “Felicitazioni ma”. In quel “ma” ci sono la diffidenza e la rabbia, e forse anche un po’ di invidia, verso chi adotta uno stile di vita divergente da quello delle persone che lo giudicano. Come ha fatto Silvia, scegliendo l’Africa al posto di un lavoro nel suo paese. Se il loro modo di vivere è giusto, il suo dev’essere per forza sbagliato, nel loro universo binario. L’ho sentito tante volte, quel “ma”, e lo trovo ogni volta più odioso. Specialmente quando riguarda una ragazza che ha vissuto un’esperienza terribile, e quando torna a casa si sente dare della “neoterrorista” persino da un deputato in Parlamento, che disonora il ruolo che riveste e chiede scusa il giorno dopo, senz’altra conseguenza. Spero che cali il sipario, sulla sua storia; che Silvia venga lasciata in pace, e sia dimenticata. Le serve tempo: soprattutto per capire se vuole davvero vivere in un paese in cui migliaia di persone in fondo l’hanno condannata prima ancora di conoscere la sua storia.