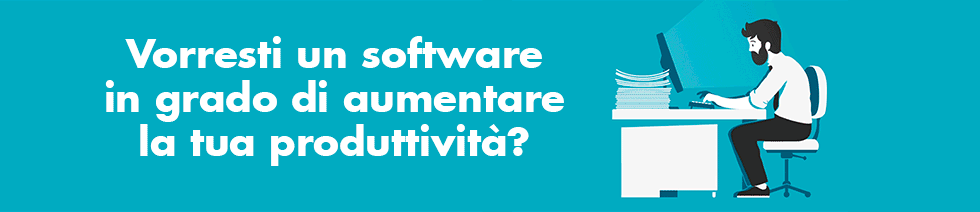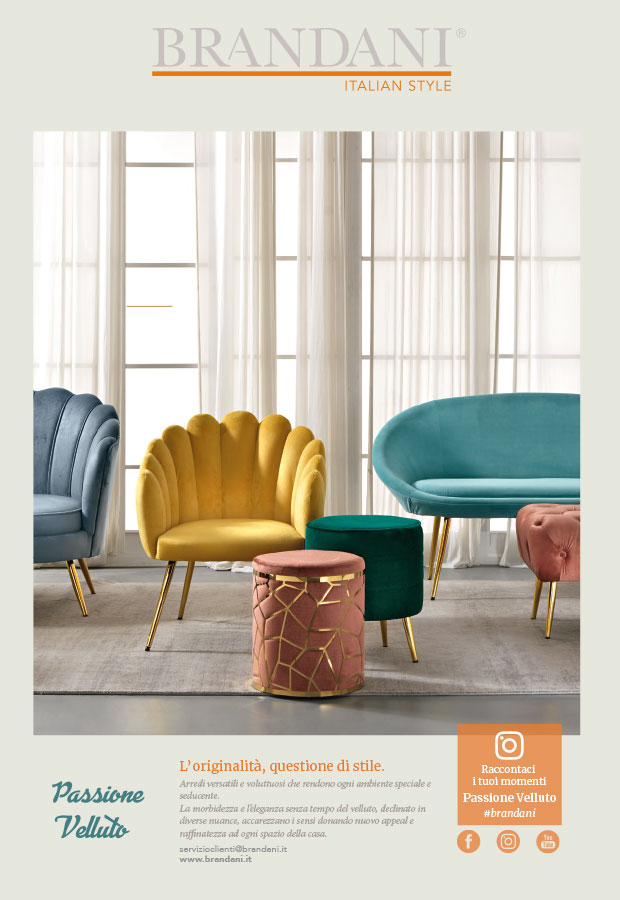Nonna non credeva nella risurrezione dei morti. Tanto meno nella vita del mondo che verrà. Suo fratello, invece, lo zio canonico, che diceva messa e si sbracciava dall’altare che pareva la Vanoni quando canta sul palco Eternità, beh, lui sì che ci credeva forte.
Ogni mattina zio si trovava davanti una ventina di monache che lo aspettavano con gli occhi lucidi su al monastero di Santa Scolastica. Le trovava serene; o sdraiate sul pavimento duecentesco o sedute in coro con il volto nascosto da certe mani candide e lisce come candele ancora non accese.
Nonna Giulia, che personalmente conosceva almeno cinque di quelle vergini che si erano buttate in età già matura tra le braccia di san Benedetto, non a torto, riteneva che avessero idee un pochino differenti alle sue in merito alla risurrezione dei morti. Non ho mai capito perché nonna fosse così interessata a tale argomento. Che io sappia, nonna non aveva particolari simpatie per i defunti o comunque questi erano argomenti che non le appartenevano. Però sicuramente a volte ci pensava su. Come tutti.
Ho sempre creduto che nonna credesse soltanto nel periodo di gestazione delle sue coniglie. O almeno io ho sempre avuto questa convinzione. Mi ricordo – avrò avuto all’incirca dodici anni – laggiù lungo la redola che portava al laghetto, sotto un capanno fatto di lamiera e legno, la fila dei gabbioni dove alloggiavano da una parte le coniglie e dall’altra i conigli; questi ultimi, immagino, impazienti di raggiungere un discreto livello ormonale per montare, sia detto con tutto il dovuto rispetto, le coniglie, pure esse calde come pop corn appena spadellati.
Ricordo le coniglie di nonna.
Forse erano una quindicina. Ne aveva di rosse, di brune, di bianche e lei le considerava tutte come fossero sue figlie o nipoti. Portavano in grembo per poco più di un mese i loro figliolini coniglini. Ricordo anche quando nonna mi diceva che una certa coniglia aveva ben oltrepassato con fiera audacia anche trentatré giorni di gestazione. Nonna diceva che quei coniglini poi sarebbero diventati squisiti e tenerissimi con le olive e con qualche foglia di orbaco, giusto per toglierli il sapore di rigno che potevano avere intorno agli ossi.
Al di là di queste cose che interessavano per lo più nonna, mi ricordo che per qualche mese smisi di andare a scuola. Andavo, ormai da qualche anno, da una psicologa, mi pare un paio di ore alla settimana. Purtroppo non ricordo il suo nome, ma accidenti se ricordo se era pisana.
Aveva un terribile accento tirrenico-pisano, che io quasi non la capivo. Ho vaghi ricordi di lei: era piuttosto alta con un volto intelligente e buffo e gli occhi erano talmente celesti che parevano strappati al più bel cielo del mondo, ed io che pensavo fosse la più bella donna che avessi mai visto. Ora mi ricordo: portava gli occhiali. E però la cosa che mi ricordo di più è che era terribilmente pisana. Anche da come gesticolava. Mi piacerebbe vederla di nuovo. Questo vorrebbe dire che ho ancora qualche tacca nel cervello. Ma io però dico: chi non ne ha?
La notte comunque dormivo tranquillo perché sapevo che l’avrei vista di nuovo di lì a qualche giorno. Portava anche certi orecchini che a me parevano piuttosto belli. Forse erano un regalo del fidanzato o del marito, non saprei dirvelo.
Non mi ricordo perché mi portarono da una psicologa pisana. Non tutte le azioni che facciamo hanno una origine razionale. Credo che mi avessero portato da lei perché abitava vicino a mia zia, pisana pure lei ed anche interista. E credo che mi avessero messo su una comoda poltrona blu a parlare con questa psicologa perché, tra le altre cose che qui taccio perché comunque mi firmo col mio nome e cognome, non mi andava di portare a scuola il grembiule nero che mi faceva sembrare un piccolo e peraltro assai bruttino becchino.
Figuriamoci come era contenta quella strega della mia sorella che doveva andare da sola a scuola a piedi senza di me, che ogni tanto le davo coraggio per la via, ed insieme si saltavano almeno tre piccoli fossi e due ponticelli in legno dove quasi sempre ci si trovava una famiglia di bodde, che secondo lei erano gigantesche e le saltavano addosso appena la vedevano. Fischio!
Figuriamoci se tanti grossi ranocchi si prendevano la briga di saltare addosso a quella strega, bruttina com’era!
Io almeno mi son sempre salvato usando il tasto della simpatia. Mia sorella non aveva e non ha nemmeno tuttora questa dote. Tre anni fa si è sposata ed il ranocchio di cui aveva un dannato terrore adesso se lo trova sotto le lenzuola insieme con lei.
Ora che ci penso, sono almeno sei anni che non parlo e non vedo mia sorella e nemmeno suo marito, un vanesio con un frammento di ferro piantato proprio lì nel mezzo della lingua. Credo faccia il commercialista o il rivenditore di pannelli solari, non lo so e detto tra noi nemmeno mi interessa. Comunque sono perfidamente contento che mia sorella lo abbia sposato. Scoccia solo che il mio cognome vada ad intrufolarsi col suo, che nemmeno so quale sia. Finisce con “ini”, credo, ma non sto nemmeno a perder tempo ora a ricordarlo.
E nemmeno a scrivere ulteriormente sul mio cognato saccente e vanesio. Meglio lasciar perdere. Così almeno diceva anche sempre nonna. Che era più cinica di me. Mi mancano le sue frasi che per me erano gelatina di aloe dopo una scottatura, definitive come il bacio dato alla fine di un breve incontro con una ragazza interessante.
Aveva ragione nonna: far finta di essere sordi oppure scemi, se proprio serviva, o comunque far capire che avevi qualche tacca nel cervello. Io, che già andavo dalla psicologa pisana, mi ritenevo, in un certo senso, avvantaggiato. Mi ero fatto, per così dire, le ossa.
Parlo più volentieri di un episodio triste che nonna mi raccontò un giorno che eravamo stati a vedere i gabbioni dei conigli. Accadde quando nonna era una ragazza. Ciò che mi disse mi lasciò scioccato. Ci riflettei su un bel mucchietto di settimane.
Non so perché nonna mi raccontò di quando un suo zio, pure lui come me non esattamente centrato di testa, una mattina che fuori pioveva forte, entrò nel fienile, chiuse l’uscio dietro di sé, lo bloccò con un paletto di faggio, legò una corda ad una trave, salì su una cassetta di legno, si passò la corda intorno al collo, strinse quanto poté e finalmente diede un bel calcio alla cassetta. Stettero ore a cercare zio, che tutti credevano fosse andato giù al fiume a nuotare insieme con la Francesca, un pochino sciroccata pure lei. Alla fine fu nonna, che all’epoca però non era nonna, a scoprire lo zio appeso alla trave.
Due giorni dopo, avendo ottenuto dal vescovo la licenza di seppellire zio in terra consacrata, lei si vestì tutta di nero e camminò con gli altri di famiglia per i viottoli laterali del cimitero a testa bassa ed a piangere lacrime grosse che parevano sassi di fiume.
Quel giorno piovve talmente tanto che i rii che giravano intorno al cimitero strariparono tutti, colmando d’acqua alcune fosse scavate in quei giorni.
Nonna diceva sempre che era semplice morire in un giorno di pioggia.
La pioggia avrebbe lavato la cassa da morto con i suoi preziosi manici di bronzo e spezzato la rigorosa simmetria dei serti di alloro e dei mazzi di fiori portati dai parenti. Nonna pensava che un funerale sotto la pioggia battente avrebbe scoraggiato chiunque dal parteciparvi.
Accadde proprio così, mi disse nonna tenendomi per mano.
In quel mentre un gatto giallo saltò nella viottola che conduceva a casa nostra e venne a strofinarsi contro le mie gambe. Io lo carezzai. Il gatto ronfava di piacere e dimenava la coda.