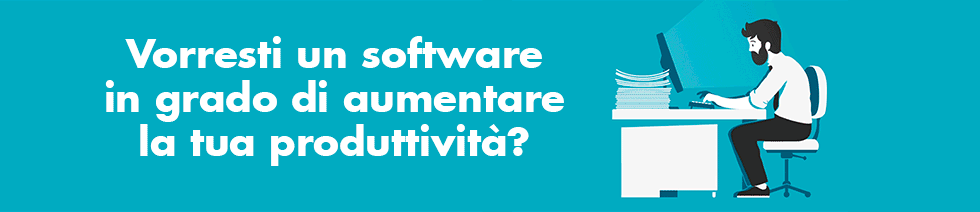Capita a tutti, nel momento in cui si cessa l’attività lavorativa, e per chi ne ha la fortuna, di scoprire un altro mondo. Magari, all’avvicinarsi di quel fatidico giorno, diversi hanno cercato di progettare, programmare il proprio futuro, lontano mille miglia da ciò che è stato fatto per decenni. Così, tutti i desideri, le voglie, i capricci, chiusi magari in un’immaginaria scatola di scarpe, si tirano fuori. Si soffia per togliere l’immaginaria polvere, e si distendono su un tavolo per dare libero sfogo a quei sogni e, possibilmente, realizzarne qualcuno. Per cominciare, l’importante è la salute, come dicono tutti da sempre. Questa è diventata un “mantra” parola induista, che viene ripetuta troppe volte per meditare, mentre basterebbe una buona regola di vita, evitando gli eccessi legati ai vizi, e dei quali ormai nessuno si stupisce più. Povera Italia: per riflettere bisogna diventare induisti.
Ma ritorniamo alla scatola. Se ripensiamo ai nostri giorni scarmigliati, all’evoluzione della vecchia corrente della scapigliatura, quelli di ieri erano banali, forse, ma genuini, semplici, e non c’erano ermi colli che li fermassero, e né discese ardite. Lo era stata, poco prima, la guerra, e chi ne era uscito si contentava del giusto, e quello chiedeva: case, strade, botteghe, due lire in tasca, spesso anche meno. Eppure, in quella situazione, i ragazzi “istintivamente” trovavano comunque il modo di giocare, divertirsi, essere liberi anche in un paesotto come Collodi, dove grandi valvole di sfogo non c’erano. Qui, di solito, i vari piccoli rioni, ed i loro giovani abitanti, si riunivano sul “Tondo”, il semicerchio di erba davanti all’ingresso del Giardino, dove si trova il Monumento ai Caduti; o nella canonica della Chiesa, per giocare soprattutto al biliardino. Solo d’estate entrava in gioco la Pescia Minore, con i bagni nella “Serra”, e la cattura dei pescatelli, rigorosamente a mano. Quindi, i nostri svaghi si limitavano a quelli classici: le palline, quelle di serie “B” di terracotta e quelli di serie “A” di vetro; su tutte queste, giganteggiava il “bocco”, le cui dimensioni erano il doppio delle prime. Poi, con i tappini e nascondino e chiappino, ma per i maschietti, il massimo era il calcio, o pallone, come si diceva allora. La difficoltà non era trovare un campetto: per quello ci si arrangiava. No, la difficoltà era proprio il pallone; chi ne aveva uno, comandava il gioco, senza se e/ senza ma, attraverso l’altruistica, classica, affermazione: “gioco, e dove mi pare, altrimenti “ciao”!
Quello con cui si giocava non era di cuoio bensì di gomma o plastica, e, andava spesso voleva lui e non le nostre scarpe. La mamma: “Bada bene di non giocare a pallone perché di scarpe ce n’è poche, hai capito?” E noi, contriti e bugiardi: “si, mamma, ma ora scappo che m’aspettano!”. Mio babbo, “pappà” in villese, aveva fatto il calzolaio: ero in una botte di ferro. Ma povere scarpe, e povera testa! Eh, sì, gli scapaccioni – al ritorno – fioccavano, e tutti noi che giocavamo li hanno presi, incartati e ricordati. Oggi, non ti azzardare a fare ciò … Così, è iniziata la crociata “politicamente corretto”, un’altra americanata di cui non ne avevamo bisogno, che mi sembra, a parte le giustissime rivendicazioni – detta papale papale – una grande … grullata di poveri storti, alla colligiana. E, legata, a questa, ecco il “contrappasso dantesco”: li abbiamo colonizzati ed ora sono loro che ci colonizzano; infatti, la prossima lingua che sarà parlata in Italy, sarà l’anglo americana. Poveri noi! Le partite di calcio, allora si giocavano nel già citato “pratino” e, soprattutto, nel piazzale della Chiesa; c’era, sì la ghiaia ma, insomma, pur con misure più grandi al pratino, le sfide erano comunque piuttosto turbolente, e si accendevano notevolmente quando il pallone varcava o meno la linea immaginaria tra i due pali, cioè sassi grossi, i tiri alti suscitavano reclami minori. Ci fu, in seguito, un leggero sviluppo quando i più grandi presero possesso del terreno che rappresentava il “giardino” delle Scuole Elementari. Era in terra battuta e loro rischiavano di meno perché noi eravamo troppo piccoli, e quindi solo spettatori. Certe domeniche pomeriggio estive si disputavano qui, con due squadre composte da 9/10 spettatori (già 5 e 5 sarebbero stati troppi!), partite accanite, con discussioni sulle formazioni, ed i gol erano rari, e frequenti le zuffe, con qualche calcio extra, vaghe minacce e rarissimi i colpi di testa. I regolamenti erano volatili, sempre discutibili, ma c’era tanta, tanta gente che assisteva. Era così che sfogavamo la nostra voglia di correre, di ridere, di illuderci che tutta la vita sarà un gioco. C’erano, sì, le lezioni da fare e qualcosa da studiare, ma la mia memoria delle Elementari è quasi tutta scomparsa, e gli alti voti della pagella non mi servirono.
Non me ne lamento. Anzi, il periodo del grembiulino nero e del fiocco azzurro lo ricordo con tanto affetto, anche per un episodio, tra quei pochi rimastimi che mi vede clamorosamente protagonista. Non ricordo se questo accadde in terza o quarta classe, e ancora non riesco a capacitarmi di aver pronunciato una frase che non so da quale angolo della testa questa sia uscita. Con il candore e l’ingenuità di un bimbetto di 8/9 anni, dissi ad una compagna: “Da grande, ti sposo!”. Et voilà, la vergogna è servita. Ho perso la memoria di cosa successe dopo quell’attimo, e di quando tutto questo poi finì. Sono, ed ero, cronicamente timido, e quindi – di regola – mai avrei approcciato una ragazzina con una promessa così forte ed impegnativa. Questa dichiarazione morì lì. Non ho ricordo ci sia stato un seguito, anche perché lei non viveva in paese. Ma ho talmente ben conservato quella gravosa richiesta che, solo recentemente, ho scoperto che il suo vero nome non era Rossana bensì Elena: quasi uno shock! Gli anni più belli della Scuola sono quelli delle Elementari? Può darsi. Allora non c’era la televisione e solo pochissime radio, con qualche transistor per “Tutto il calcio minuto per minuto”. Eppure, ci divertivamo lo stesso perché il futuro non ci interessava e, soprattutto, non premeva sul nostro quotidiano. Cominciavano a circolare anche alcune fotografie; all’epoca, quelle erano assai care ed è per questo che, almeno io, ne ho conservate poche, anche perché si sono salvate quelle che i genitori hanno messo in proprio dentro una scatola di scarpe, e sono così sfuggite al lavorìo del tempo e all’incuria di noi ragazzini. In più, Collodi era un paese autosufficiente, una piccola cittadina perché c’era tutto ciò che serviva, e anche di più. Fornaio, alimentari, sarto, macellaio, frantoio, cartiere, filanda, ufficio postale, stazione dei carabinieri con relativo carcere, granaio, mulino, pesciaio, corbellaio, officina, bar, ristorante e albergo, cinema e sala da ballo, idraulico, falegname, muratori e addirittura, un piccolo teatrino a Borghetti, cos’ come lo spazzino comunale, il Temperani.
Poco tempo fa, il mio carissimo amico Sauro, ben conosciuto per essere un uomo di poche parole (!), ricordava come lo spazzino pesciatino teneva la città più pulita di oggi, e così era anche Collodi. Definendoli, ipocritamente, operatori ecologici, è una magia che inganna in quanto non possono rendere migliore il loro servizio perché siamo noi che rendiamo indecente questa realtà: il benessere fa aumentare lo sporco, o forse funzionava meglio la parola spazzino di quella di operatore? Su tutto il paese collodese vegliano le meraviglie della Villa e del Giardino Garzoni, famiglia di origini pesciatina che si rifugiò a Lucca perché cacciata dai Guelfi fiorentini. Qui, vi lavoravano quotidianamente diversi giardinieri e camerieri; fino a pochi decenni fa, la proprietà era passata ai Gardi dell’Ardeghesca: quando, chiunque sia, riuscirà a rendere questo complesso stupendo come lo è stato per secoli? Alla fine degli anni ’50 del secolo scorso ebbe però inizio, con Pinocchio, una trasformazione che ridimenzionò la tranquilla vita della frazione, proiettandola in un circuito turistico che l’ha resa famosa perdendo quel tran tran campagnolo in cui tutti si conoscevano e si aiutavano: finiva l’umanità paesana. Naturalmente, questo sommovimento interessò anche il mio futuro. Era partita la mia passioncella per il football, che prese corpo il 19 ottobre 1955 quando fu inaugurato il bellissimo “Stadio dei Fiori” e mandò in pensione il vecchio campo che si trovava in piazza Leonardo da Vinci.
Quello, incantò tutta la città e i suoi borghi tanto da spingere la vecchia società dell’U.S. Pescia a cercare di primeggiare sulle altre squadre della Valdinievole. Famose, e ormai storiche, le rivalità, e le partite al color bianco con il Borgo a Buggiano, il Montecatini, il Monsummano, la Chiesina Uzzanese e il Ponte Buggianese. Tutto questo mi coinvolse, ci coinvolse perché si sparse la voce che erano necessari, durante le gare ufficiali, i raccattapalle. L’eco arrivò anche nel mio paese, e fu così che mi ritrovai, al cancello dell’ingresso delle squadre, con diversi bimbetti su per giù della mia stessa età, un’ora prima dell’orario della partita. Non conosceva nessuno, e io ero solo perché, con il consenso dei miei, mi recavo a piedi da casa al campo sportivo. Così fu per quasi tutti gli incontri casalinghi anche se era il tempo, bello o brutto che decideva per noi. Quanto impegno, quante partecipazione nel raccogliere la sfera calciata fuori dallo specchio della porta! Raccattapalle il pallone di cuoio, color marrone, chiuso con un filo dello stesso materiale, e lo riportavamo al portiere. E forse a causa di questa cucitura che, nel mio trascorso pallonaro, raramente colpivo la palla di testa; e, quando caso mai succedeva, l’impatto con il “coso” mi lasciava stupito per averlo colpito, e assai dolorante sulla fronte, su cui rimaneva l’impronta del laccio. Quel branchetto di ragazzini, che si presentava una domenica sì e l’altra no, come da calendario, trovava, inoltre, alla fine dell’incontro, un’altra grande soddisfazione. Mentre il custode Pellegro inforcava la bici per “spogliare” i pali dalle corde che li rivestiva, rimaneva un pallone a nostra disposizione; noi ne approfittavamo e, formate le squadre, si giocava una partitella nell’area di rigore opposta a quella dove lui lavorava. Fu il mio inizio nel mondo del calcio, che mi terrà compagnia per 50 anni. Riordinando il mio modesto passato fotografico, mi è capitata tra le mani una bustina di plastica azzurra con dentro una foto minima di cm. 10×7, e assai usurata nei bordi. Nel suo retro c’era scritto, con una calligrafia un po’ così: avviamento 2 – Medie 1, 1959. Si riconoscono, a stento, i volti, e l’unico in borghese credo fosse Luca Bernardini con il pallone sottobraccio. Una foto minima, rigorosamente in bianco e nero, e gli 11 giocatori che indossavano magliette diverse l’uno dall’altro tanto da non riconoscere nemmeno il portiere.
E proprio nella stagione calcistica 1959-60 fui tesserato dai rossoneri. Allora, l’età minima per giocare ufficialmente era quella di aver compiuto i 14 anni di età. Essendo nato la fine di novembre, giocai 3 partite prima del compleanno e queste furono così perse a tavolino. Questa piccolissima foto (scattata da chi?) È stato un tuffo profondissimo nel mio passato, ahimè remoto, e l, pur se mi riconosco a malapena, mi sembra di rivivere un mezzo miracolo. In più, a questa immagine è legato il mio percorso scolastico. Dopo aver concluso le Elementari, avrei dovuto continuare gli studi a Pescia, ma c’era un particolare che segnò il mio futuro, forse nel bene, forse nel male, non so. Nel presentarmi, come tutti gli alunni del comune in possesso della licenza elementare nell’edificio scolastico in Piazza XX Settembre, ci fu richiesto di scrivere un temino che avrebbe deciso quale percorso avremmo fatto nei prossimi 3 anni. Un esame? Un esamino? Era, per me, un fatto eccezionale che mi emozionò enormemente. Fu così che non lo superai e, quindi, fu decisa la mia iscrizione non alle Medie ma all’Avviamento.
Io capii ben poco di quel movimento, e così mi ritrovai, con ragazzi anche più grandi di me, nella classe 1. B, intruppato nella piccola folla che entrava nell’edificio dalla porta laterale della scuola, quella in via Roma al civico n.6. Se ricordo bene, quelli che frequentavano le Medie entravano dal portone principale. Il mio percorso fu, perciò abbastanza duro, disseminato di esami di riparazione, ma, onestamente, non ne fui particolarmente dispiaciuto. Non mi rendevo conto di cosa significasse perdere buona parte dell’estate per rimediare le zoppìe dimostrate durante l’anno scolastico anche se, ovviamente, un certo cruccio lo provai. Ricordo ancora il maestro Aldi, la cui abitazione era frequentata da numerosi rimandati e il cui figlio giocò all’ala sinistra nella squadra del Delfino, e raramente imbrattava i suoi calzoncini bianchi. Non fu una passeggiata; di certo, non lo vissi come un dramma, e anche questo fatto mi fa capire quale sia oggi la sciagura, la vergogna, il dispetto di non accettare di fare una fermata per recuperare ciò che non si è capito. Cosa mi rimase di quel triennio? Una bella foto della classe 3. B, scattata nel corridoio esterno, quello che dà su Piazza del Grano. Eravamo in 18, più la prof.ssa Puccioni e il prof. Magnanensi (se ricordo bene), e tutti sorridevamo; l’unico veramente triste era Tito Pellegrini, forse presago. Ecco, di queste cose mi sembra di riconoscere solo il Marini, il 4° i piedi da sinistra, di coloro che parteciparono al derby Avviamento-Medie disputato al Comunale. Vincemmo 2 a 1 e tutto finì lì.
Vennero le vacanze per i promossi, gli esami di riparazione per i rimandati, e, ad ottobre, le strade ci avevano già diviso. A volte, ho incrociato qualche vecchio compagno. Un saluto banale e poche altre chiacchere, perché quella poesia nata in classe se ne andò proprio alla fine di quella partita di calcio; ma rimanevano sempre gli stessi interrogativi: sì, ci conosciamo, ma quanto tempo è passato? E il suo nome, mi dispiace, non lo ricordo più. E lui, si ricorda di me? Domande che rimanevano senza risposte. E’ così: questa è la regola. Quanto più allontaniamo, tanto più dimentichiamo. Leggo di cene organizzate per riscoprire tutti insieme le emozioni di decenni fa, ma ne sono moto scettico. Ci salutiamo. Si mangia e si beve qualcosa. Il più brillante parla quasi per tutti, ma l’atmosfera, le piccole gioie, i piccoli dolori; gli affetti, le simpatie, le curiosità; quelle che andavano a settembre, e gli insegnanti, dove sono finiti? E’ tutto passato perché quello strappo non può essere ricucito. Si dovrebbe continuare a frequentarci; magari, fare le superiori insieme, per continuare a riparlare di cosa sono stati le Medie e l’Avviamento, e questo è già un fatto rarissimo. Sì, ci ricordiamo di qualcuno che era un po’ stravagante; di un altro troppo timido; del bravo e del peggiore; e di quel prof. o prof.ssa verso i quali avevamo più simpatia, o antipatia. Eppure, questa piccolissima foto qualcosa ha smosso dentro. Ci avviamo alla fine degli anni ’50, e tutto intorno c’era movimento. “Nascevano” i motorini, per chi poteva. Le macchine cominciavano a fare la differenza. L’età cresceva, anche se i segni ed i progetti rimanevano piccolini. Si rinviava la maturazione, che oggi mi sembra troppo anticipata, rimanendo ancora attaccati, a quel tenero infantilismo protettivo, tanto c’erano sempre i genitori e gli amici. Con i primi timidi amorini, le improvvise cottarelle, che facevano arrossire e battere forte il cuore senza capirne il perché. Una foto piccolissima, con un gruppetto di ragazzi, di tanti anni fa; ritrovata per caso e che, dimostrando tutta la sua veneranda età, mi riporta ad un mondo che sembrava più leggero, più lento, più felice.
Quante emozioni e quando commozione in quel ritrattino in bianco e nero che racchiude l’età dell’oro della vita perché inconsci che quella stesse finendo. Il vento si stava alzando, e cominciava la lotta per la vita.
Franco Corsetti