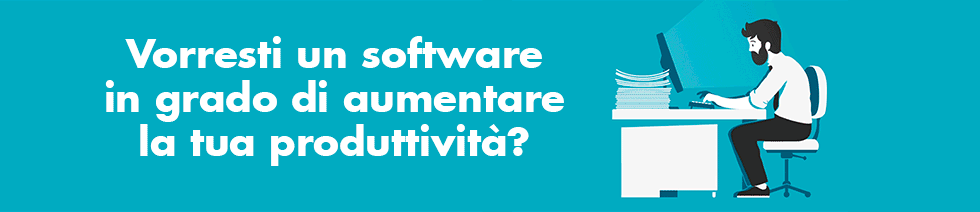Secondo un dato diffuso dal MIUR il 5% delle scuole urbane si trova in aree degradate, in zone cioè classificate come a rischio disagio. Il dato riguarda soprattutto le città con più di 250.000 abitanti, e specificamente alcune zone del paese dove i problemi legati a dispersione scolastica, microcriminalità, disoccupazione e altro sono più radicati. I dati relativi agli istituti scolastici derivano dall’incrocio dei risultati delle prove INVALSI, degli Esami di Stato, del tasso di abbandono e di altri indicatori che consentono di tracciare un profilo abbastanza scoraggiante di cosa sia diventata la scuola in certe aree del paese: non più ascensore sociale ma parcheggio, non più veicolo di promozione personale ma ente assistenziale con finalità che non le sono proprie.
Per questo motivo periodicamente gli osservatori del mondo della scuola, che facciano parte della stessa o meno, ripropongono l’idea di diversificare gli stipendi dei docenti a seconda del luogo in cui operano, in modo da premiare quelli che scelgono di rimanere a lungo in istituti che si trovino in aree problematiche o ospitino una popolazione studentesca bisognosa di attenzioni particolari.
Questo perché è ben noto il fenomeno per cui, appena si creano i presupposti per farlo, molti docenti presentano domanda di trasferimento, per insediarsi in scuole dove lavorare più serenamente; e poiché sono nel pieno diritto di farlo nessuno si sogna di muover loro una critica.
Tuttavia, la continuità didattica, la conoscenza dei problemi che affliggono gli istituti e i loro studenti, il rapporto che si crea col tessuto vivo del territorio vengono meno, e non è un problema di poco conto. Perché spesso il ruolo di questi docenti va ben oltre la mera funzione didattica; essi diventano un punto di riferimento non solo per i ragazzi ma spesso per le loro famiglie, e penso che l’importanza di questo ruolo non vada riconosciuta solo socialmente, ma anche economicamente. Se non si può obbligare un docente a non presentare domanda di trasferimento, in altre parole, va spronato con ogni mezzo, e non è detto che funzioni, a restare dove si trova anche se la scuola in cui insegna annega nelle difficoltà.
C’è poi un altro aspetto da considerare; spesso in questo tipo di contesti scolastici il carico di lavoro è maggiore, e non solo dal punto di vista emotivo e psicologico. I ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali), quelli con disabilità cognitive, quelli provenienti da situazioni di disagio socioeconomico o in condizioni di svantaggio linguistico perché stranieri, per una serie di motivi raramente si iscrivono nelle istituzioni scolastiche considerate “alte” (si legga licei), ma prediligono istituti tecnici e professionali; e va da sé che nelle aree dove il disagio socioeconomico è alto la concentrazione di studenti con questo tipo di caratteristiche è maggiore. Per ognuno di loro bisogna attivare progetti, predisporre piani di lavoro differenziati o personalizzati, seguire corsi di formazione; per questi oneri burocratici in più è prevista una remunerazione, tuttavia spesso si percepisce un certo malcontento verso quei colleghi più “fortunati” che tali oneri non ce li hanno.
Ma è poi proprio una fortuna, lavorare in scuole dove i problemi siano pochi e di scarsa entità? O forse, invece, il bello del lavoro del docente è proprio quello di tirar fuori il meglio da ragazzi e ragazzi da cui in fondo nessuno si aspetta nulla? In altri termini: la soddisfazione deve limitarsi al riconoscimento economico, magari maggiorato, o c’è molto altro? Propendo per la seconda via, pur dichiarandomi favorevole a intervenire sulla prima.
Su Facebook c’è un profilo che si chiama “Portami il diario”; lo ha aperto una professoressa che si chiama Valentina Petri, e che dalla sua esperienza ha anche tratto due romanzi pubblicati da Rizzoli. Insegna in un professionale di Vercelli, e in ogni suo post ci consegna il ritratto di una torma di studenti forse poco attenti alla forma e al verseggiare dei poeti antichi, ma certo vivi e veraci nella loro autenticità. Io che in un istituto professionale ho insegnato diversi anni, e che poi ho finito per mettere radici in un tecnico, posso confermare che non sento alcun bisogno di cambiare, perché penso di poter essere più utile dove sono adesso; con studenti che magari partono più svantaggiati dei loro coetanei liceali, ma che negli anni quel divario lo colmano, e alla grande, e mi ripagano con un affetto che non è così scontato trovare nella scuola di oggi.
Stefania Berti